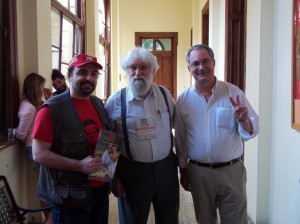“Mai avere paura della tenerezza”
intervista a papa Francesco
a cura di Andrea Tornielli
in “La Stampa” del 15 dicembre 2013
dopo l’intervista a : E. Scalfari su ‘la Repubblica’, ora l’intervista ad A. Tornielli su ‘la Stampa’ da parte di papa Francesco che conferma così una modalità di evangelizzazione molto immediata, informale e attenta all’uso dei mass media:
«Il Natale per me è speranza e tenerezza…». Francesco racconta a «La Stampa» il suo primo Natale
da vescovo di Roma. Casa Santa Marta, martedì 10 dicembre, ore 12.50. Il Papa ci accoglie in una
sala accanto al refettorio. L’incontro durerà un’ora e mezzo. Per due volte, durante il colloquio, dal
volto di Francesco sparisce la serenità che tutto il mondo ha imparato a conoscere, quando accenna
alla sofferenza innocente dei bambini e alla tragedia della fame nel mondo. Nell’intervista il Papa
parla anche dei rapporti con le altre confessioni cristiane e dell’«ecumenismo del sangue» che le
unisce nella persecuzione, accenna alle questioni su matrimonio e famiglia che saranno trattate dal
prossimo Sinodo, risponde a chi lo ha criticato dagli Usa definendolo «un marxista» e parla
del rapporto tra Chiesa e politica.
Che cosa significa per lei il Natale?
«È l’incontro con Gesù. Dio ha sempre cercato il suo popolo, lo ha condotto, lo ha custodito, ha
promesso di essergli sempre vicino. Nel Libro del Deuteronomio leggiamo che Dio cammina con
noi, ci conduce per mano come un papà fa con il figlio. Questo è bello. Il Natale è l’incontro di Dio
con il suo popolo. Ed è anche una consolazione, un mistero di consolazione. Tante volte, dopo la
messa di mezzanotte, ho passato qualche ora solo, in cappella, prima di celebrare la messa
dell’aurora. Con questo sentimento di profonda consolazione e pace. Ricordo una volta qui a Roma,
credo fosse il Natale del 1974, una notte di preghiera dopo la messa nella residenza del Centro
Astalli. Per me il Natale è sempre stato questo: contemplare la visita di Dio al suo popolo».
Che cosa dice il Natale all’uomo di oggi?
«Ci parla della tenerezza e della speranza. Dio incontrandoci ci dice due cose. La prima è: abbiate
speranza. Dio apre sempre le porte, mai le chiude. È il papà che ci apre le porte. Secondo: non
abbiate paura della tenerezza. Quando i cristiani si dimenticano della speranza e della tenerezza,
diventano una Chiesa fredda, che non sa dove andare e si imbriglia nelle ideologie, negli
atteggiamenti mondani. Mentre la semplicità di Dio ti dice: vai avanti, io sono un Padre che ti
accarezza. Ho paura quando i cristiani perdono la speranza e la capacità di abbracciare e
accarezzare. Forse per questo, guardando al futuro, parlo spesso dei bambini e degli anziani, cioè
dei più indifesi. Nella mia vita di prete, andando in parrocchia, ho sempre cercato di trasmettere
questa tenerezza soprattutto ai bambini e agli anziani. Mi fa bene, e mi fa pensare alla tenerezza che
Dio ha per noi».
Come si può credere che Dio, considerato dalle religioni infinito e onnipotente, si faccia così
piccolo?
«I Padri greci la chiamavano “synkatabasis”, condiscendenza divina. Dio che scende e sta con noi.
È uno dei misteri di Dio. A Betlemme, nel 2000, Giovanni Paolo II disse che Dio è diventato un
bambino totalmente dipendente dalle cure di un papà e di una mamma. Per questo il Natale ci dà
tanta gioia. Non ci sentiamo più soli, Dio è sceso per stare con noi. Gesù si è fatto uno di noi e per
noi ha patito sulla croce la fine più brutta, quella di un criminale».
Il Natale viene spesso presentato come fiaba zuccherosa. Ma Dio nasce in un mondo dove c’è
anche tanta sofferenza e miseria.
«Quello che leggiamo nei Vangeli è un annuncio di gioia. Gli evangelisti hanno descritto una gioia.
Non si fanno considerazioni sul mondo ingiusto, su come faccia Dio a nascere in un mondo così.
Tutto questo è il frutto di una nostra contemplazione: i poveri, il bambino che deve nascere nella
precarietà. Il Natale non è stata la denuncia dell’ingiustizia sociale, della povertà, ma è stato un
annuncio di gioia. Tutto il resto sono conseguenze che noi traiamo. Alcune giuste, altre meno giuste,
altre ancora ideologizzate. Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace.
Quando non si ha la capacità o si è in una situazione umana che non ti permette di comprendere questa gioia, si vive la festa con l’allegria mondana. Ma fra la gioia profonda e l’allegria mondana
c’è differenza».
È il suo primo Natale, in un mondo dove non mancano conflitti e guerre…
«Dio mai dà un dono a chi non è capace di riceverlo. Se ci offre il dono del Natale è perché tutti
abbiamo la capacità di comprenderlo e riceverlo. Tutti, dal più santo al più peccatore, dal più pulito
al più corrotto. Anche il corrotto ha questa capacità: poverino, ce l’ha magari un po’ arrugginita, ma
ce l’ha. Il Natale in questo tempo di conflitti è una chiamata di Dio, che ci dà questo dono.
Vogliamo riceverlo o preferiamo altri regali? Questo Natale in un mondo travagliato dalle guerre, a
me fa pensare alla pazienza di Dio. La principale virtù di Dio esplicitata nella Bibbia è che Lui è
amore. Lui ci aspetta, mai si stanca di aspettarci. Lui dà il dono e poi ci aspetta. Questo accade
anche nella vita di ciascuno di noi. C’è chi lo ignora. Ma Dio è paziente e la pace, la serenità della
notte di Natale è un riflesso della pazienza di Dio con noi».
In gennaio saranno cinquant’anni dallo storico viaggio di Paolo VI in Terra Santa. Lei ci
andrà?
«Natale sempre ci fa pensare a Betlemme, e Betlemme è in un punto preciso, nella Terra Santa dove
è vissuto Gesù. Nella notte di Natale penso soprattutto ai cristiani che vivono lì, a quelli che hanno
difficoltà, ai tanti di loro che hanno dovuto lasciare quella terra per vari problemi. Ma Betlemme
continua a essere Betlemme. Dio è venuto in un punto determinato, in una terra determinata, è
apparsa lì la tenerezza di Dio, la grazia di Dio. Non possiamo pensare al Natale senza pensare alla
Terra Santa. Cinquant’anni fa Paolo VI ha avuto il coraggio di uscire per andare là, e così è
cominciata l’epoca dei viaggi papali. Anch’io desidero andarci, per incontrare il mio fratello
Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, e con lui commemorare questo cinquantenario rinnovando
l’abbraccio tra Papa Montini e Atenagora avvenuto a Gerusalemme nel 1964. Ci stiamo
preparando».
Lei ha incontrato più volte i bambini gravemente ammalati. Che cosa può dire davanti a
questa sofferenza innocente?
«Un maestro di vita per me è stato Dostoevskij, e quella sua domanda, esplicita e implicita, ha
sempre girato nel mio cuore: perché soffrono i bambini? Non c’è spiegazione. Mi viene questa
immagine: a un certo punto della sua vita il bambino si “sveglia”, non capisce molte cose, si sente
minacciato, comincia a fare domande al papà o alla mamma. È l’età dei “perché”. Ma quando il
figlio domanda, poi non ascolta tutto ciò che hai da dire, ti incalza subito con nuovi “perché?”.
Quello che cerca, più della spiegazione, è lo sguardo del papà che dà sicurezza. Davanti a un
bambino sofferente, l’unica preghiera che a me viene è la preghiera del perché. Signore perché? Lui
non mi spiega niente. Ma sento che mi guarda. E così posso dire: Tu sai il perché, io non lo so e Tu
non me lo dici, ma mi guardi e io mi fido di Te, Signore, mi fido del tuo sguardo».
Parlando della sofferenza dei bambini non si può dimenticare la tragedia di chi soffre la fame.
«Con il cibo che avanziamo e buttiamo potremmo dar da mangiare a tantissimi. Se riuscissimo a
non sprecare, a riciclare il cibo, la fame nel mondo diminuirebbe di molto. Mi ha impressionato
leggere una statistica che parla di 10 mila bambini morti di fame ogni giorno nel mondo. Ci sono
tanti bambini che piangono perché hanno fame. L’altro giorno all’udienza del mercoledì, dietro una
transenna, c’era una giovane mamma col suo bambino di pochi mesi. Quando sono passato, il
bambino piangeva tanto. La madre lo accarezzava. Le ho detto: signora, credo che il piccolo abbia
fame. Lei ha risposto: sì sarebbe l’ora… Ho replicato: ma gli dia da mangiare, per favore! Lei aveva
pudore, non voleva allattarlo in pubblico, mentre passava il Papa. Ecco, vorrei dire lo stesso
all’umanità: date da mangiare! Quella donna aveva il latte per il suo bambino, nel mondo abbiamo
sufficiente cibo per sfamare tutti. Se lavoriamo con le organizzazioni umanitarie e riusciamo a
essere tutti d’accordo nel non sprecare il cibo, facendolo arrivare a chi ne ha bisogno, daremo un
grande contributo per risolvere la tragedia della fame nel mondo. Vorrei ripetere all’umanità ciò che
ho detto a quella mamma: date da mangiare a chi ha fame! La speranza e la tenerezza del Natale del
Signore ci scuotano dall’indifferenza».
Alcuni brani dell’«Evangelii Gaudium» le hanno attirato le accuse degli ultra-conservatori
americani. Che effetto fa a un Papa sentirsi definire «marxista»?«L’ideologia marxista è sbagliata. Ma nella mia vita ho conosciuto tanti marxisti buoni come
persone, e per questo non mi sento offeso».
Le parole che hanno colpito di più sono quelle sull’economia che «uccide»…
«Nell’esortazione non c’è nulla che non si ritrovi nella Dottrina sociale della Chiesa. Non ho parlato
da un punto di vista tecnico, ho cercato di presentare una fotografia di quanto accade. L’unica
citazione specifica è stata per le teorie della “ricaduta favorevole”, secondo le quali ogni crescita
economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione
sociale nel mondo. C’era la promessa che quando il bicchiere fosse stato pieno, sarebbe trasbordato
e i poveri ne avrebbero beneficiato. Accade invece che quando è colmo, il bicchiere magicamente
s’ingrandisce, e così non esce mai niente per i poveri. Questo è stato l’unico riferimento a una teoria
specifica. Ripeto, non ho parlato da tecnico, ma secondo la dottrina sociale della Chiesa. E questo
non significa essere marxista».
Lei ha annunciato una «conversione del papato». Gli incontri con i patriarchi ortodossi le
hanno suggerito qualche via concreta?
«Giovanni Paolo II aveva parlato in modo ancora più esplicito di una forma di esercizio del primato
che si apra ad una situazione nuova. Ma non solo dal punto di vista dei rapporti ecumenici, anche
nei rapporti con la Curia e con le Chiese locali. In questi primi nove mesi ho accolto la visita di tanti
fratelli ortodossi, Bartolomeo, Hilarion, il teologo Zizioulas, il copto Tawadros: quest’ultimo è un
mistico, entrava in cappella, si toglieva le scarpe e andava a pregare. Mi sono sentito loro fratello.
Hanno la successione apostolica, li ho ricevuti come fratelli vescovi. È un dolore non poter ancora
celebrare l’eucaristia insieme, ma l’amicizia c’è. Credo che la strada sia questa: amicizia, lavoro
comune, e pregare per l’unità. Ci siamo benedetti l’un l’altro, un fratello benedice l’altro, un fratello
si chiama Pietro e l’altro si chiama Andrea, Marco, Tommaso…».
L’unità dei cristiani è una priorità per lei?
«Sì, per me l’ecumenismo è prioritario. Oggi esiste l’ecumenismo del sangue. In alcuni paesi
ammazzano i cristiani perché portano una croce o hanno una Bibbia, e prima di ammazzarli non gli
domandano se sono anglicani, luterani, cattolici o ortodossi. Il sangue è mischiato. Per coloro che
uccidono, siamo cristiani. Uniti nel sangue, anche se tra noi non riusciamo ancora a fare i passi
necessari verso l’unità e forse non è ancora arrivato il tempo. L’unità è una grazia, che si deve
chiedere. Conoscevo ad Amburgo un parroco che seguiva la causa di beatificazione di un prete
cattolico ghigliottinato dai nazisti perché insegnava il catechismo ai bambini. Dopo di lui, nella fila
dei condannati, c’era un pastore luterano, ucciso per lo stesso motivo. Il loro sangue si è mescolato.
Quel parroco mi raccontava di essere andato dal vescovo e di avergli detto: “Continuo a seguire la
causa, ma di tutti e due, non solo del cattolico”. Questo è l’ecumenismo del sangue. Esiste anche
oggi, basta leggere i giornali. Quelli che ammazzano i cristiani non ti chiedono la carta d’identità
per sapere in quale Chiesa tu sia stato battezzato. Dobbiamo prendere in considerazione questa
realtà».
Nell’esortazione lei ha invitato a scelte pastorali prudenti e audaci per quanto riguarda i
sacramenti. A che cosa si riferiva?
«Quando parlo di prudenza non penso a un atteggiamento paralizzante, ma a una virtù di chi
governa. La prudenza è una virtù di governo. Anche l’audacia lo è. Si deve governare con audacia e
con prudenza. Ho parlato del battesimo, e della comunione come cibo spirituale per andare avanti,
da considerare un rimedio e non un premio. Alcuni hanno subito pensato ai sacramenti per i
divorziati risposati, ma io non sono sceso in casi particolari: volevo solo indicare un principio.
Dobbiamo cercare di facilitare la fede delle persone più che controllarla. L’anno scorso in Argentina
avevo denunciato l’atteggiamento di alcuni preti che non battezzavano i figli delle ragazze madri. È
una mentalità ammalata».
E quanto ai divorziati risposati?
«L’esclusione della comunione per i divorziati che vivono una seconda unione non è una sanzione.
È bene ricordarlo. Ma non ho parlato di questo nell’esortazione».
Ne tratterà il prossimo Sinodo dei vescovi?
«La sinodalità nella Chiesa è importante: del matrimonio nel suo complesso parleremo nelle riunioni del concistoro in febbraio. Poi il tema sarà affrontato al Sinodo straordinario dell’ottobre
2014 e ancora durante il Sinodo ordinario dell’anno successivo. In queste sedi tante cose si
approfondiranno e si chiariranno».
Come procede il lavoro dei suoi otto «consiglieri» per la riforma della Curia?
«Il lavoro è lungo. Chi voleva avanzare proposte o inviare idee lo ha fatto. Il cardinale Bertello ha
raccolto i pareri di tutti i dicasteri vaticani. Abbiamo ricevuto suggerimenti dai vescovi di tutto il
mondo. Nell’ultima riunione gli otto cardinali hanno detto che siamo arrivati al momento di
avanzare proposte concrete, e nel prossimo incontro, in febbraio, mi consegneranno i loro primi
suggerimenti. Io sono sempre presente agli incontri, eccetto la mattina del mercoledì per via
dell’udienza. Ma non parlo, ascolto soltanto, e questo mi fa bene. Un cardinale anziano alcuni mesi
fa mi ha detto: “La riforma della Curia lei l’ha già cominciata con la messa quotidiana a Santa
Marta”. Questo mi ha fatto pensare: la riforma inizia sempre con iniziative spirituali e pastorali
prima che con cambiamenti strutturali».
Qual è il giusto rapporto fra la Chiesa e la politica?
«Il rapporto deve essere allo stesso tempo parallelo e convergente. Parallelo, perché ognuno ha la
sua strada e i suoi diversi compiti. Convergente, soltanto nell’aiutare il popolo. Quando i rapporti
convergono prima, senza il popolo, o infischiandosene del popolo, inizia quel connubio con il
potere politico che finisce per imputridire la Chiesa: gli affari, i compromessi… Bisogna procedere
paralleli, ognuno con il proprio metodo, i propri compiti, la propria vocazione. Convergenti solo nel
bene comune. La politica è nobile, è una delle forme più alte di carità, come diceva Paolo VI. La
sporchiamo quando la usiamo per gli affari. Anche la relazione fra Chiesa e potere politico può
essere corrotta, se non converge soltanto nel bene comune».
Posso chiederle se avremo donne cardinale?
«È una battuta uscita non so da dove. Le donne nella Chiesa devono essere valorizzate, non
“clericalizzate”. Chi pensa alle donne cardinale soffre un po’ di clericalismo».
Come procede il lavoro di pulizia allo Ior?
«Le commissioni referenti stanno lavorando bene. Moneyval ci ha dato un report buono, siamo sulla
strada giusta. Sul futuro dello Ior si vedrà. Per esempio, la “banca centrale” del Vaticano sarebbe
l’Apsa. Lo Ior è stato istituito per aiutare le opere di religione, missioni, le Chiese povere. Poi è
diventato come è adesso».
Un anno fa poteva immaginare che il Natale 2013 lo avrebbe celebrato in San Pietro?
«Assolutamente no».
Si aspettava di essere eletto?
«Non me l’aspettavo. Non ho perso la pace mentre crescevano i voti. Sono rimasto tranquillo. E
quella pace c’è ancora adesso, la considero un dono del Signore. Finito l’ultimo scrutinio, mi hanno
portato al centro della Sistina e mi è stato chiesto se accettavo. Ho risposto di sì, ho detto che mi
sarei chiamato Francesco. Soltanto allora mi sono allontanato. Mi hanno portato nella stanza
adiacente per cambiarmi l’abito. Poi, poco prima di affacciarmi, mi sono inginocchiato a pregare
per qualche minuto insieme ai cardinali Vallini e Hummes nella cappella Paolina».