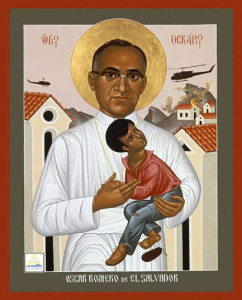di Jon Sobrino
Il mio primo incontro personale con monsignor Romero avvenne il 12 marzo 1977. Quel pomeriggio padre Rutilio Grande e due contadini, un bambino e un anziano, erano stati assassinati vicino a El Paisnal. La sera ci riunimmo in molti nel convento di Aguilares, gesuiti, sacerdoti, religiose e centinaia di contadini, a piangere la morte di Rutilio, il sacerdote che aveva annunciato la buona notizia del Vangelo.
Stavamo aspettando monsignor Romero, che aveva preso possesso dell’arcidiocesi pochi giorni prima, il 22 febbraio, e il suo vescovo ausiliare monsignor Rivera, per celebrare la prima eucaristia davanti ai cadaveri dei tre assassinati. (…). Bussarono alla porta del convento, andai ad aprire e monsignor Romero entrò, insieme a monsignor Rivera. Il volto di monsignor Romero era serio e pieno di preoccupazione. Lo salutai e senza dire una parola lo accompagnai in chiesa. Fu il mio primo contatto personale con monsignor Romero. Fu breve, solo simbolico, però l’occasione lo fece diventare molto importante per me.
Indubbiamente in quei momenti il nostro pensiero andava a Rutilio e ai contadini assassinati. Tutti ci chiedevamo che cosa ci avrebbe riservato il futuro: infatti, sebbene la repressione contro i contadini fosse già cominciata e alcuni sacerdoti fossero già stati arrestati ed espulsi dal Paese, per El Salvador l’assassinio di un sacerdote era un fatto inaudito. Venivano meno non soltanto le regole del bene, ma anche quelle del male. Se i potenti si erano spinti ad assassinare un sacerdote, nel Paese sarebbe potuta accadere qualsiasi cosa. Di fatto il 1977, per i contadini, per i sacerdoti e anche per noi gesuiti, fu un anno davvero tribolato. Due mesi dopo vennero espulsi dal Paese i tre gesuiti che erano rimasti ad Aguilares e il 20 giugno tutti noi gesuiti fummo minacciati di morte.
Senz’altro la cosa più importante di quella notte era il cadavere di Rutilio. Per me, tuttavia, fu importante anche guardare il volto serio e preoccupato di monsignor Romero. Quel vescovo, del quale io sapevo solo che era stato molto conservatore e fragile psicologicamente, cominciava il suo ministero arcivescovile non tra celebrazioni solenni ma tra sequestri, torture, espulsioni di sacerdoti e, ora, davanti al sangue di uno dei sacerdoti che aveva conosciuto meglio: Rutilio. E, ancor peggio, in mezzo a una crescente repressione di contadini e operai, che i vescovi, particolarmente motivati da monsignor Rivera, avevano denunciato coraggiosamente in un messaggio del 5 marzo.
Il volto serio e preoccupato di monsignor Romero quando gli aprii la porta mi attrasse subito, e dentro di me, pensai che avrei dovuto aiutarlo. Di fatto l’idea che tutti noi ci eravamo fatti di lui era già cambiata nelle riunioni col clero che si erano tenute negli ultimi giorni di febbraio, dove si era presentato come nuovo arcivescovo e ci aveva chiesto di aiutarlo in quelle gravi difficoltà. La decisione di aiutarlo era stata spontanea e condivisa da molti. Per tutti noi era anche una necessità, dato che presagivamo che le cose si sarebbero fatte molto difficili: meglio affrontarle uniti come Chiesa, piuttosto che separati e divisi. (…). Ma quella notte del 12 marzo fu decisiva. E devo dire che quel cambiamento fu sorprendente, perché le mie scarse relazioni con lui erano state piuttosto tese dal mio rientro nel Salvador, nel 1974.
A quell’epoca di monsignor Romero avevo saputo soltanto che era un vescovo molto influenzato dall’Opus Dei, contrario – a volte con aggressività intellettuale – ai sacerdoti e ai vescovi che avevano accettato la linea di Medellín. Considerava marxisti e politicizzati diversi gesuiti del Salvador, proprio quelli dai quali stavo imparando a muovere i miei primi passi di gesuita e di teologo, dopo sette anni di assenza. (…).
Questo trovò conferma il 6 agosto 1976. Quel giorno si celebra la festa del Divino Salvatore, patrono del Paese, con un’immancabile messa solenne. In quegli anni si invitava un’importante personalità ecclesiale a tenere l’omelia in presenza di tutti i vescovi, del governo e del corpo diplomatico. (…).
Se mi si permette una parentesi, l’omelia del 1970 era stata pronunciata da padre Rutilio Grande, noto e apprezzato sacerdote dell’arcidiocesi e candidato a diventare rettore del seminario. Rutilio aveva dedicato la sua omelia a commentare le tre parole che sono scritte sulla bandiera nazionale: Dio, unità, libertà. Quell’omelia fu una forte denuncia della situazione del Paese: senza unità e senza libertà, e, pertanto, senza Dio. L’omelia aveva causato grande sorpresa e un grande impatto; e Rutilio non divenne rettore del seminario. Tornando al 1976, questa volta l’oratore sacro scelto fu monsignor Romero, allora vescovo di Santiago de Maria. Non assistetti alla messa del 6 agosto, ma poche ore dopo la celebrazione un sacerdote mi portò la registrazione dell’omelia. L’ascoltai e rimasi di sasso. Nel primo punto dell’omelia, monsignor Romero criticava le cristologie sviluppate nel Paese: cristologie razionaliste, cristologie inneggianti alla rivoluzione, cristologie che portavano odio… In altre parole, la sua omelia era stata un’accesa critica della mia cristologia.
Quindi è comprensibile che non vedessimo di buon occhio la scelta di monsignor Romero come successore dell’arcivescovo Luis Chávez, che era stato un vescovo pastorale, molto vicino al popolo, col quale avevamo ottimi rapporti. (…). Mi domandai se monsignor Romero avrebbe avuto il coraggio di denunciare la repressione o se, al contrario, l’avrebbe agevolata; se avrebbe difeso i contadini e i sacerdoti minacciati. Pochi giorni dopo ricevetti una cartolina da un gesuita messicano, che quasi mi faceva le condoglianze. Tutti, in effetti, vedevamo un panorama triste. Fortunatamente ci sbagliavamo.
Questi ricordi, ovviamente, in quella sera del 12 marzo non avevano alcuna importanza. (…).
In quei momenti cominciò a venirmi in mente un altro pensiero, importante solo a livello personale. Sapevo che monsignor Romero aveva avuto l’umiltà e la delicatezza di chiedere scusa per le sue azioni precedenti. Era giunto, con parecchi anni di ritardo, a chiedere perdono a una comunità di base, per quanto aveva detto nel 1972: parole che in pratica giustificavano la militarizzazione dell’Università nazionale e la repressione che ne era scaturita. Chiese perdono anche a un compagno gesuita che era rettore del seminario quando i vescovi – e tra loro, con forza, monsignor Romero – avevano deciso che i gesuiti abbandonassero la direzione del seminario. E c’erano stati altri analoghi casi di umiltà e sensibilità.
Non so perché, mi turbava l’idea che un giorno monsignor Romero potesse rievocare i suoi attacchi contro di me e chiedermi scusa. Fortunatamente non l’ha mai fatto, e ne sono stato sollevato. Però ricordo un giorno, credo fosse la fine di aprile del 1977, in cui monsignor Romero mi vide in un angolo della cattedrale e venne a parlarmi. «La ringrazio» mi disse, «per la riflessione che ha fatto sulla Chiesa. Credo abbia aiutato molto». Si riferiva al dossier che aveva spedito a Roma per spiegare la situazione del Paese e l’azione ecclesiale dopo la morte di Rutilio. Io avevo collaborato per la parte della riflessione teologica.
In verità monsignor Romero non aveva bisogno di ringraziare né me né tanti altri per esserci posti al suo servizio. Ma il suo gesto mi fece piacere: era una specie di accettazione ecclesiale di quanto facevamo e, soprattutto, un gesto di fiducia. (…).
LA CONVERSIONE
Ritorniamo alla sera del 12 marzo. Dopo la messa, monsignor Romero chiese ai sacerdoti e ai religiosi di rimanere lì con lui; si fermarono anche alcuni contadini e laici, naturalmente senza alcuna discriminazione. (…). Ci pose una domanda elementare: che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare, come Chiesa, dopo la morte di Rutilio.
Mi resi conto che, per quanto potesse essere nervoso e turbato, era disposto a compiere tutto il necessario, sebbene il solo pensiero probabilmente lo terrorizzasse: infatti era giunto il momento di affrontare i potenti, l’oligarchia e il governo. E senza dubbio ricordo che le parole con cui ci chiedeva aiuto erano totalmente sincere, gli venivano dal cuore. Un arcivescovo ci chiedeva veramente aiuto. E lo chiedeva a coloro che qualche settimana prima aveva considerato sospetti, marxisti… Quel gesto di dialogo e di umiltà mi arrecò una grande gioia. E pensavo che benché apparentemente per monsignor Romero tutto iniziasse tanto male, in realtà iniziava bene. Germogliava il seme di una Chiesa unita, determinata e profetica, che in seguito sarebbe cresciuto tanto. (…).
Sentii anche, o almeno intuii, che nel suo intimo stava accadendo qualcosa di profondo. Certamente era nervoso, però credo che in quel nervosismo e in quel non sapere che cosa fare di quei primi momenti, monsignor Romero abbia preso l’intima decisione di reagire come Dio gli domandava: fece una vera scelta per i poveri, rappresentati in quella notte da centinaia di contadini radunati intorno a tre cadaveri, indifesi davanti alla repressione che già subivano e che prevedevano. (…). Credo che quella notte iniziò a maturare definitivamente la conversione di monsignor Romero.
In effetti monsignor Romero non gradiva che si parlasse di una sua «conversione», e non aveva tutti i torti. Era solito ricordare che proveniva da una famiglia umile, che non era mai vissuto nella ricchezza e abbondanza, ma nella povertà e nell’austerità. Inoltre tutti riconoscevano che la sua vita sacerdotale ed episcopale fin lì era stata notevolmente virtuosa. A suo modo era stato aperto verso i poveri e li aveva anche difesi a Santiago de Maria, nel momento della repressione. (…). Credo inoltre che monsignor Romero abbia sempre mantenuto un cuore puro e un discernimento morale che né la sua ideologia conservatrice né l’agire retrogrado di buona parte della gerarchia a cui apparteneva erano valsi a soffocare. Tuttavia la sua personalità interiore era come sdoppiata: nel cuore manteneva gli ideali religiosi, accettava le direttive del Vaticano II e di Medellín, ma la sua mente interpretava la novità del Concilio e di Medellín in una prospettiva assai conservatrice, impaurita di qualsiasi cosa potesse immischiare la Chiesa nella cruda realtà conflittuale e ambigua della storia. Fu questo sdoppiamento interiore, credo, a dissolversi quella notte, e direi che questo si possa chiamare conversione; non tanto come chi smetta di fare il male e abbracci il bene, ma come un radicale cambiamento nel cogliere e nel porre in opera la volontà di Dio. (…).
Lo si chiami o non lo si chiami conversione, il radicale cambiamento di monsignor Romero è uno degli avvenimenti che più hanno colpito tutti, me compreso. In quel momento monsignor Romero aveva cinquantanove anni, età in cui le persone hanno già consolidato la propria struttura psicologica e mentale, la loro comprensiöne della fede, la spiritualità e l’impegno cristiano. Inoltre era arcivescovo di fresca nomina, vale a dire che era stato posto come massima autorità e responsabile dell’istituzione ecclesiale, che, come tutte le istituzioni, è più propensa alla continuità e alla prudenza, se non al passo del gambero. Infine, le circostanze storiche non erano affatto favorevoli. Monsignor Romero fu pienamente consapevole, fin dal principio, di essere stato il candidato della destra, e subito conobbe le adulazioni dei potenti che gli offrirono la costruzione di un palazzo episcopale sperando che cambiasse linea rispetto al suo predecessore, Luis Chávez y Gonzáles. Cambiare, e cambiare radicalmente, significava non solo deluderli (…), bensì anche affrontarli. Se avesse cambiato, si sarebbe attirato le ire dei potenti, dell’oligarchia, del governo, dei partiti politici, dell’esercito e dei corpi di sicurezza; e, poi, della maggioranza dei suoi fratelli vescovi, di vari dicasteri vaticani e perfino del governo degli Stati Uniti. Se per spiegarci la sua conversione soppesiamo le forze in campo, monsignor Romero aveva dalla sua un gruppo di sacerdoti e religiose e, certamente, il dolore e la speranza di tutto un popolo; ma dalla parte avversa erano schierati tutti i potenti. L’equilibrio evangelico delle forze andava a suo favore, ma non quello storico. Se monsignor Rornero si è lanciato per strade così nuove alla sua età, dal punto più alto dell’istituzione e con tanti sicuri avversari, vuol dire che la sua conversione è stata piena e reale, ha toccato il più profondo del suo essere, l’ha definito per sempre e l’ha portato fino al dono della vita. (…).
Credo che l’assassinio di Rutilio Grande – che è stato anche luce e incoraggiamento per i suoi successivi percorsi – sia stato l’occasione della conversione di monsignor Romero. Monsignor Romero conosceva molto bene Rutilio, lo considerava un sacerdote esemplare e un amico (…). Tuttavia monsignor Romero non aveva condiviso la pastorale di Rutilio negli anni in cui quest’ultimo era stato parroco ad Aguilares: la considerava troppo politicizzata, troppo orizzontale, lontana dalla missione fondamentale della Chiesa e pericolosamente vicina alle idee rivoluzionarie. Rutilio fu quindi per monsignor Romero un «problema»; più ancora, un «enigma». Per un verso era un sacerdote virtuoso, zelante, davvero credente; per l’altro verso la sua missione pastorale pareva, a Romero, scorretta e sbagliata. Quell’«enigma», credo, si chiarì con l’assassinio di Rutilio. Credo che davanti al cadavere di Rutilio a monsignor Romero siano cadute le bende dagli occhi: Rutilio aveva ragione. (…). Insomma, a sbagliare non era stato Rutilio Grande, ma Oscar Romero; non Rutilio doveva cambiare, ma lui stesso. E queste riflessioni, che in teoria sarebbero potute restare sul mero piano razionale, si tradussero in decisioni di cambiamento, di proseguire la linea di Rutilio e, soprattutto, la strada di Gesù. (…). Credo che la morte di Rutilio abbia scosso monsignor Rornero e gli abbia dato la forza per un nuovo modo di agire, e che la vita di Rutilio abbia impresso la direzione fondamentale anche alla sua vita, benché egli dovesse poi tradurla in atto nella sua situazione personale di arcivescovo e nelle circostanze storiche sempre più critiche. In quei giorni si parlava della conversione di monsignor Romero come del «miracolo di Rutilio».
Una seconda cosa che dovette colpire a fondo monsignor Romero in quei primi giorni da vescovo fu la differente reazione dei diversi gruppi ecclesiali. Monsignor Rornero era al corrente del fatto che la sua nomina non era stata ben accolta, che i sacerdoti «progressisti», le comunità di base e tutti coloro che lavoravano nella linea della coscientizzazione e liberazione di Medellín, lo avevano accolto con timore. E conosceva anche le aspettative che la sua nomina aveva risvegliato nei cattolici accomodanti – quelli a volte conniventi con i gruppi di potere che avevano attaccato e calunniato monsignor Chávez – e nel gruppetto di sacerdoti collocabili in quell’orbita. Dovette rimanere davvero sorpreso nel constatare che, in quei giorni tanto duri per lui e densi di rischi concreti, i primi lo avevano accolto e i secondi lo avevano abbandonato. Nell’ora della verità, quelli che aveva guardato con sospetto, che aveva combattuto, e anche accusato e condannato, restavano con lui. Gli altri, coloro che giudicava pii e ortodossi, i prudenti e i non politicizzati, gli apparentemente fedeli a qualsiasi indicazione della Chiesa, lo lasciavano solo, come i discepoli con Gesù; e presto cominciarono a criticarlo, ad attaccarlo, a disobbedirgli (dimostrando così che la loro asserita fedeltà alla gerarchia ecclesiastica finiva quando l’arcivescovo non era di loro gradimento e le cose si mettevano male).
(…). Non si poteva dedurne che tutto quanto facevano i sacerdoti progressisti era perfetto; però se ne ricavava, almeno, che avevano molta più verità e molto più amore cristiano rispetto agli altri. (…). E che erano disposti a correre rischi personali, a parlare e a denunciare pubblicamente, sebbene in quel momento ciò comportasse essere schedati, arrestati o assassinati. (…).
Ricordo che una sera, pochi giorni dopo l’assassinio di Rutilio, lo incontrai alla Ysax – la radio dell’arcivescovado, molto nota perché ritrasmetteva le omelie di monsignor Romero e per i tanti attentati dinamitardi – e mi mostrò una lettera, su carta lussuosa e, se non ricordo male, adorna con disegni di fiori. La lettera era di una persona che era stata vicina a monsignor Romero. Questa si mostrava sorpresa del suo cambiamento e non condivideva il suo modo di agire. Monsignor Romero non si mostrò per nulla colpito. Ricordo che mi disse semplicemente: «È di una persona dell’Opus». Credo intendesse dirmi che «non capisce, come neanch’io prima capivo».
(…). Coloro che abbandonarono il Paese alla sua tragedia, nascondendosi nel loro essere cristiani, per monsignor Romero smisero di essere luce. Quelli che scelsero in favore del Paese, dicendo la verità, denunciando le atrocità e impegnandosi nella giustizia – con tutti i loro limiti e le loro esagerazioni -, per monsignor Romero divennero luce.
Un terzo elemento che spiega la conversione di Romero, quella definitiva e che lo mantenne fedele alla volontà di Dio fino alla fine, sono stati i poveri del suo popolo. Subito gli mostrarono accoglienza, appoggio, tenerezza e amore. (…). Appena monsignor Romero fece i suoi primi passi, appena fece le sue prime denunce e le prime visite alle comunità, i poveri si volsero a lui, entrarono nel suo cuore e vi rimasero. Monsignor Romero a sua volta entrò nel loro cuore, dov’è rimasto fino a oggi. (…). I poveri gli imposero di convertirsi; e tuttavia, offrendogli al tempo stesso luce e salvezza, gliela resero una via agevole. E monsignor Romero lo riconobbe. Per me non c’è dubbio che qui risieda il definitivo segreto di monsignor Romero, come lui stesso ha affermato. Con parole straordinariamente appropriate, parole che non ci si può inventare se non scaturiscono dalla verità nel cuore, ha detto: «Con questo popolo non pesa essere un buon pastore».
LA VERA “GLORIA DI DIO”
Nei giorni successivi l’assassinio di Rutilio, la curia arcivescovile e tutta la diocesi vissero momenti di grande fermento, che a loro volta tracciarono per monsignor Romero una traiettoria che poi percorse sino alla fine senza deflettere. Capì ben presto che in quanto arcivescovo doveva spiegare al popolo che cos’è la Chiesa, la sua denuncia profetica e la difesa dei poveri. (…).
Rompendo molti anni di tradizione, monsignor Romero fece il gesto davvero straordinario di promettere pubblicamente che non avrebbe partecipato ad alcuna cerimonia ufficiale del governo finché quei crimini non fossero stati chiariti e non si fosse interrotta la repressione. Mantenne la parola: in tre anni non partecipò ad alcun atto del governo, non l’approvò con la sua presenza.
Queste prime azioni di monsignor Romero cominciavano a mostrare quale sarebbe stato il suo modo di agire. Prendeva decisioni sul da farsi dopo averne discusso e dialogato con il clero, le religiose e i laici. Ricordo che una delle riunioni di quei primi giorni durò dalle otto di mattina fino alle otto di sera. Fin dal principio il suo modo di fare fu profetico, denunciando con chiarezza le aberrazioni; fu evangelico, con semplicità, senza lasciarsi intimidire dalle conseguenze politiche delle sue azioni; fu pubblico, parlando al Paese, promettendo cose verificabili, che gli si sarebbero potute contestare se non le avesse realizzate.
Fra ciò che ha promesso pubblicamente e ha mantenuto, in quei giorni, spiccarono due cose: la sospensione delle lezioni per tre giorni nelle scuole cattoliche e la messa unica del 20 marzo (in segno di protesta per l’assassinio di Rutilio Grande, fu stabilita la celebrazione di un’unica messa domenicale, di funerale, in tutta l’arcidiocesi, NdT).
La sospensione delle lezioni non fu una vacanza, come dissero i suoi detrattori, ma tre giorni di studio, riflessione e preghiera sulla Bibbia, sul Concilio e su Medellín. (…).
La messa unica causò maggior agitazione, e penso che quella decisione sia stata molto importante per monsignor Romero, perché lo portò a confrontarsi con la sua stessa fede e cominciò a metterlo a confronto con l’istituzione ecclesiastica. (…). Era convinto di dover fare qualcosa d’importante, che richiamasse l’attenzione del Paese e risvegliasse le coscienze; ma aveva uno scrupolo teologico che formulò nella riunione, con la sincerità che lo caratterizzava: «Se l’eucaristia è un atto nel quale si dà gloria a Dio, non gli darà maggior gloria la molteplicità abituale delle messe domenicali?» (…). Ci fu una lunga discussione, fin quando padre Jerez prese la parola e disse: «Io credo che monsignor Romero abbia ragione nel sostenere che dobbiamo preoccuparci della gloria di Dio, però, se non ricordo male, i padri della Chiesa dicevano gloria Dei vivens homo, la gloria di Dio è l’uomo vivente». Quest’intervento in pratica chiuse la discussione. Monsignor Romero parve convinto e sollevato dal suo scrupolo, e decise che si sarebbe celebrata la messa unica. (…).
Non si trattava soltanto di accettare una nuova formulazione teologica, ma una nuova comprensione di Dio. E monsignor Romero l’accettò. Ha ripetuto fino alla sazietà che per Dio non c’è nulla di più importante della vita dei poveri. (…). Ha riformulato il detto di sant’Ireneo citato da padre Jerez come gloria Dei vivens pauper, «la gloria di Dio è il povero che vive». E all’opposto si è scagliato contro gli idoli, le divinità false ma molto reali, che producono morte e per sussistere esigono vittime.
Credo che a cinquantanove anni monsignor Romero non soltanto abbia attraversato una conversione, ma abbia anche fatto una nuova esperienza di Dio. Da allora non poté più separare Dio dai poveri, la sua fede in Dio dalla difesa dei poveri. Credo che abbia visto in Dio il prototipo dell’opzione per i poveri, e che questo l’abbia indotto a metterla in pratica per primo, ma l’abbia anche illuminato su chi è Dio. Sicché non lo spaventavano più le nuove formulazioni su Dio: Dio di vita, Dio del Regno, Dio dei poveri; le faceva proprie in tutta naturalezza. (…).
Tutto questo però gli fece approfondire anche il mistero del Dio sempre maggiore, trascendente, ultima sede della verità, della bontà, dell’umanità su cui gli esseri umani possono contare. (…). Il 10 febbraio 1980, in una situazione ormai caotica, in pieno conflitto con il governo, l’esercito, l’oligarchia e gli Stati Uniti, monsignor Romero fu ancora una volta profeta valoroso e implacabile: parlò delle cose di questo mondo e si schierò in difesa del suo popolo oppresso. Ma in quella stessa omelia, con la medesima naturalezza con cui pronunciava le sue denunce storiche, disse le seguenti parole: «Come vorrei, cari fratelli, che il frutto di questa predicazione di oggi, per ciascuno di noi, fosse che giungessimo a incontrare Dio e a vivere la gloria della sua maestà e della nostra piccolezza! Nessun uomo si conosce finché non ha incontrato Dio».
Chi pronuncia queste parole ha una profonda esperienza di Dio. In nome di Dio monsignor Romero ha difeso la vita dei poveri: e quando voleva offrire a tutti il meglio di se stesso, ci offriva semplicemente Dio.
Il Dio dei poveri e il mistero di Dio: ecco che cosa monsignor Romero fece presente a tutti quelli che desideravano ascoltarlo. (…).
IL CONFLITTO CON I VESCOVI
Fu tale il tumulto suscitato dall’annuncio della messa unica, che monsignor Romero decise di comunicarlo personalmente al nunzio e mi chiese di accompagnarlo insieme ad altri sacerdoti. Il nunzio non c’era e ci ricevette il suo segretario. Notai che fin dall’inizio il segretario della nunziatura era visibilmente arrabbiato per la messa unica e non faceva alcuno sforzo per nasconderlo, benché fosse davanti a monsignor Romero: lui un semplice segretario, monsignor Romero l’arcivescovo di San Salvador. È stata un’esperienza di quel po’ di arroganza che con frequenza esiste nelle curie d’ogni tipo, insieme alla mancata comprensione della sofferenza di un popolo e della condizione di un arcivescovo tormentato da responsabilità tanto serie. Credo di essermi indignato poche volte come mi è accaduto quel giorno.
Il segretario cominciò col dire che l’argomentazione pastorale e teologica a favore della messa unica era buona; credo abbia detto addirittura che era molto buona. (…). «Eppure», aggiunse, «voi avete dimenticato la cosa più importante». Non riuscivo a immaginare che cosa potesse essere più importante in quei momenti, ma il segretario sentenziò: «Avete dimenticato l’aspetto canonico». Non potevo credere a quel che sentivo, e come me nessuno dei presenti. Gli risposi che non c’è niente di più importante del corpo di Cristo che veniva represso e dissanguato nel Paese; che nulla era più importante per la Chiesa, in quei momenti, che denunciare la repressione e dare speranza al popolo; che in simili occasioni gli aspetti canonici erano secondari; gli ricordai quanto detto da Gesù sul fatto che il sabato è per l’uomo. (…).
Fu un’ora lunga e molto sgradevole, ma quel che mi impressionò di più fu l’assoluto silenzio di monsignor Romero durante tutto il tempo. (…). Conclusa la riunione, senza alzare la voce, senza entrare in discussioni sugli argomenti, disse più o meno queste parole: «Il Paese sta attraversando una situazione eccezionale di denuncia ed evangelizzazione. Io sono il responsabile dell’arcidiocesi e celebreremo la messa unica». (…). «Non capiscono» mi disse laconicamente, riferendosi alla nunziatura.
Il 20 marzo si tenne la messa unica, e fu un successo pastorale senza precedenti. (…). Con quella messa, per monsignor Romero iniziò anche un lungo calvario di incomprensione e rifiuto gerarchico. (…). Nel Salvador soltanto monsignor Rivera gli rimase fedele. (…).
Dal Vaticano gli inviarono tre visitatori apostolici in un anno e mezzo, con grande stupore dei salvadoregni che si domandavano quando sarebbe stato mandato anche un solo visitatore alle diocesi che non avevano alcun piano pastorale e a volte avallavano le azioni di un esercito criminale. A Roma le sue relazioni col cardinal Baggio furono molto tese. Il cardinale giunse a parlargli perfino della possibilità che fosse nominato un amministratore apostolico – con pieni poteri -, ipotesi di fronte alla quale monsignor Romero chiese soltanto che la cosa fosse fatta con dignità, affinché il suo popolo non ne soffrisse, benché non credesse che quella fosse una soluzione valida. (…).
Monsignor Romero scoprì quindi, proprio quando meno se l’aspettava, i limiti, gli intrighi e le meschinità dell’istituzione ecclesiale. Gli era difficile capire come fosse possibile che mentre il Paese era in fiamme e persino i sacerdoti venivano assassinati, lui trovasse non appoggio ma opposizione; come fosse possibile che mentre era in gioco il regno di Dio, i vescovi salvadoregni si preoccupassero che non accadesse nulla all’istituzione. Questo lo fece soffrire molto e negli ultimi tempi provava una vera e propria nausea all’idea di partecipare alle riunioni della Conferenza episcopale, perché vi si parlava una lingua totalmente diversa dalla sua. (…).
Ho partecipato alla Conferenza di Puebla insieme ad altri teologi e sociologi per seguire più da vicino un avvenimento tanto importante e per offrire aiuto ai vescovi che l’avessero richiesto, dato che non eravamo stati invitati a partecipare ufficialmente. Una sera si tenne una riunione congiunta tra il nostro gruppo e un buon numero di vescovi che erano venuti a trovarci. (…). C’era anche monsignor Romero. (…). Ricordo che monsignor Romero era emozionato da tutto. Dalla fraternità della riunione, dalla sincerità delle nostre discussioni, dall’ambiente di fede e di Chiesa, soprattutto dalla vicinanza e solidarietà che mostravano i vecovi. Quasi con le lacrime agli occhi, disse: «Mi sono trovato come un fratello tra altri fratelli vescovi».
(…) In breve tempo monsignor Romero dovette imparare a prendere, in prima persona, decisioni importanti e a dialogare con i suoi sacerdoti; dovette imparare la serenità per non aggravare la situazione e il coraggio per denunciare e affrontare i potenti; dovette imparare a dare speranza al popolo e a ricevere dal popolo la sua sofferenza, la sua fede e il suo impegno.
Questo è quanto si notava esteriormente. Interiormente dovette apprendere la fede nel Dio dei poveri e nel Dio maggiore di tutto, anche delle sue idee precedenti e della stessa Chiesa, che per lui iniziava a prendere l’aspetto della croce. Dovette apprendere che non c’è nulla di più importante del regno di Dio, della vita, della speranza, dell’amore e della fraternità. Dovette apprendere che il luogo della Chiesa è la sofferenza dei poveri, la realtà dei popoli crocifissi, vero servo di Yahweh, come lui stesso avrebbe detto in seguito. Dovette apprendere non soltanto a dare, ma anche a ricevere luce e salvezza da quel popolo crocifisso. E lo apprese. (…).