celebrare la passione di Gesù in tempi di coronavirus
“la passione nei giorni del coronavirus”
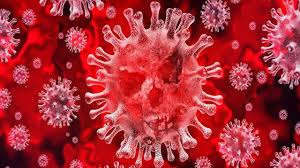
nella Bibbia per 365 volte risuona questo saluto divino: «Non aver paura!». È quasi il «buongiorno» che Dio ripete a ogni alba. Lo ripete anche in questi giorni di terrore

il Dio cristiano è diverso dalle divinità antiche come Giove, relegate nel loro mondo olimpico dorato, apatici rispetto alle sofferenze umane. È, invece, un Dio che ha scelto di assumere la stessa nostra carta d’identità, fatta, sì, anche di gioia, ma soprattutto di limite, di dolore e di morte

una bella riflessione di Gianfranco Ravasi
Scrivo con imbarazzo queste righe. Mi pareva, infatti, di sentire la voce, roca per il troppo urlare, di Giobbe che rigettava le parole degli amici teologi venuti a confortarlo definendole «decotti di malva», incapaci di spegnere il suo dolore lacerante. Oppure, iniziando a scrivere qualche riga, sentivo risuonare nell’orecchio la frase aspra di un altro sapiente biblico, Qohelet, che mi ammoniva: «Tutte le parole sono logore e l’uomo non può più usarle» (1,8).
Alla fine ho deciso di squarciare lo stesso il silenzio, come hanno fatto il Papa e tanti altri pastori con parole intense, solo per dire che tutti proviamo nell’anima gli stessi brividi dei tanti ammalati con la bocca incollata a un respiratore. E soprattutto per essere spalla a spalla con la folla di parenti, amici, vicini paralizzati dalla sofferenza dei loro cari, impossibilitati a dare una sola carezza su quei volti o persino ad accompagnarli alla fine con un rito di commiato.
Ma c’è un’altra ragione che invita tutti noi (per ora) sani a non tacere ed è proprio legata agli imminenti giorni della Settimana Santa, quando davanti a noi camminerà Cristo nelle sue ultime ore terrene. Lo immagino come nel film Andrej Rublëv del grande regista russo Andrej Tarkovskij, mentre avanza incespicando nella neve colorandola col sangue delle sue ferite, trascinando a fatica la croce, seguito dalla folla dei poveri contadini e degli ultimi di quelle terre.
Il Dio cristiano è diverso dalle divinità antiche come Giove, relegate nel loro mondo olimpico dorato, apatici rispetto alle sofferenze umane. È, invece, un Dio che ha scelto di assumere la stessa nostra carta d’identità, fatta, sì, anche di gioia, ma soprattutto di limite, di dolore e di morte. Anche se lontani dalle chiese deserte, sentiremo dalla voce del sacerdote solitario il racconto evangelico di quelle ore ultime di un Dio veramente fratello dell’umanità. E vedremo sfilare davanti agli occhi, vissute in lui, tutte le desolazioni di questi nostri giorni.

Anche lui ha paura e fin orrore della morte, il cui volto severo si presenta davanti a lui e a noi, nonostante l’avessimo prima esorcizzato e ignorato: «Padre, se è possibile, passi da me questo calice» avvelenato. Anche lui sperimenta l’isolamento degli amici, i discepoli, che rimangono lontani, o, come nel caso di tante persone sole malate, lo abbandonano. Anche lui ha la carne ferita dalle torture e prova persino la peggiore delle solitudini, il silenzio del Padre («Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»).
Alla fine anche lui, a causa della crocifissione, muore come molti malati di coronavirus, per asfissia, dopo aver emesso un respiro estremo. Aveva ragione un teologo martire del nazismo, il tedesco Dietrich Bonhoeffer, quando nel suo diario in carcere scriveva: «Dio in Cristo non ci salva in virtù della sua onnipotenza, ma in forza della sua impotenza». Sì, perché in quei momenti non si china su qualche malato per guarirlo, come aveva fatto durante la sua vita terrena, ma diventa lui stesso sofferente e mortale. Non ci libera dal male ma è con noi nel male fisico e interiore.
Eppure, anche quando è un cadavere sballottato qua e là, come accade oggi alle vittime del virus, egli è sempre il Figlio di Dio. È per questo che – sperimentando nella sua carne la nostra umanità misera, fragile e mortale – ha deposto in essa per sempre un seme di eternità e di speranza destinato a sbocciare. È questo il senso della Pasqua, «l’altra faccia della vita rispetto a quella rivolta verso di noi», come diceva il poeta austriaco Rainer M. Rilke.
Tante altre cose ha insegnato questo male a chi crede e anche a chi non crede. Ci ha, infatti, svelato la grandezza della scienza ma anche i suoi limiti; ha riscritto la scala dei valori che non ha al suo vertice il denaro o il potere; lo stare in casa insieme, padri e figli, giovani e anziani, ha riproposto fatiche e gioie delle relazioni non solo virtuali; ha semplificato il superfluo e ci ha insegnato l’essenzialità; ci ha costretti a fissare negli occhi dei nostri cari la stessa nostra morte; ci ha resi fratelli e sorelle dei tanti Giobbe, dandoci il diritto persino di protestare con Dio, di alzare le nostre domande e lamenti a lui.
Ma soprattutto ha rivelato un valore supremo, l’amore. Molti dei lettori conoscono il romanzo dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez, L’amore al tempo del colera (1982), un titolo che potrebbe essere trascritto per il coronavirus. Un titolo che è verità soprattutto nei tanti medici, infermieri, volontari, operatori vari, pronti ad andare oltre la legge dell’«amare il prossimo come se stessi», per seguire quella estrema di Gesù: «Non c’è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici».
Nella Bibbia per 365 volte risuona questo saluto divino: «Non aver paura!». È quasi il «buongiorno» che Dio ripete a ogni alba. Lo ripete anche in questi giorni di terrore. E per chi ha perso la fede proporrei, invece, la confessione dello stesso scrittore García Márquez: «Sfortunatamente, Dio non ha uno spazio nella mia vita. Nutro la speranza, se esiste, d’avere io uno spazio nella sua».

 «Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato»
«Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato»











