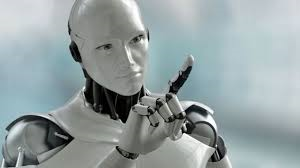quale modello di chiesa?
una proposta che viene da lontano
di Mariangela Regoliosi
in “Viandanti” – www.viandanti.org
Papa Francesco, da quando è papa, invoca una riforma interiore della Chiesa, una chiesa che, con riferimento al bellissimo capitolo 2 della lettera ai Filippesi, si metta alla sequela di un Dio “svuotato” della sua gloria e potenza divina, fatto servo, umiliato e obbediente fino alla morte, e si adegui a quel modello, e non al modello del potere, della ricchezza, dell’autoritarismo. È un messaggio forte, ma, paradossalmente, non nuovo. È vecchio come il Vangelo, solo che ci voleva questo papa per farci ritrovare il senso autentico di parole e messaggi ormai consumati dall’uso e pertanto privi di forza. Ma è vecchio anche perché è stato ripetuto nei secoli da voci piene di saggezza e di passione ecclesiale, spesso soffocate da altre voci, ma poi riemerse e di nuovo sotterrate. Un fiume carsico di spirito evangelico che per fortuna anima da sempre la Chiesa. Voglio oggi far emergere una di queste voci, lontana nel tempo eppure ancora straordinariamente efficace.
L’innovativa ricerca dell’umanesimo
Il Quattrocento italiano è uno dei secoli della nostra storia peggio conosciuto e più misinterpretato. Considerato da una parte come “il secolo senza poesia”, dall’altra come un periodo di pura erudizione filologica. Gli studi seri hanno al contrario evidenziato la vivace attività letteraria di molti umanisti e, specialmente, la innovativa riflessione filosofico-teologica dei migliori intellettuali, indispensabile antecedente di molta, e più nota, successiva riflessione europea. Uno dei capostipiti di questa svolta ideologica è senz’altro Lorenzo Valla (1407-1457) e a lui si deve la lezione di ecclesiologia di cui intendo parlare. Lo scritto più immediatamente significativo in questo senso è certamente il De falso credita et ementita Constantini donatione (Intorno alla donazione di Costantino, falsamente ritenuta vera e inventata in modo menzognero). Fu composto nel 1440 “su commissione” del re presso cui il Valla allora viveva, Alfonso d’Aragona, per scardinare le rivendicazioni feudali di papa Eugenio IV sul Regno di Napoli, basate appunto sullo pseudo-documento, per secoli creduto autentico, della donazione da parte dell’imperatore Costantino alla chiesa di Roma dei possedimenti dell’intero Occidente. Ben lungi dall’essere un astioso pamphlet politico – come ancora taluni critici recenti vanno scrivendo – il De donatione è innanzitutto un testo scientifico, perché dimostra con prove inoppugnabili (storiche-logiche-linguistiche-stilistiche-ideologiche) la falsità del documento. Ma è anche – ciò che qui maggiormente interessa – un testo religioso di rinnovamento ecclesiale. Una denuncia contro il temporalismo In una serie di orazioni fittizie, messe in bocca ai protagonisti stessi della vicenda pseudo-storica (re e principi detentori del potere civile, i figli dell’imperatore Costantino, il Senato e il popolo di Roma, e infine il destinatario dell’ipotetica donazione, papa Silvestro) il Valla tende a dimostrare, oltre alle prove fattuali, la improbabilità, incredibilità, e quindi inverosimiglianza storica della cosiddetta donazione. In particolare, a fronte della essenza spirituale della Chiesa, quale emerge dalla Sacra Scrittura e dall’esempio del Cristo fondatore, risulta altamente improbabile, se non impossibile, che un papa abbia potuto liberamente accettare un dominio terreno in assoluto contrasto con la sua autentica vocazione religiosa. Anzi, è proprio da questa contrapposizione, tra la “logica” del potere umano e la “logica” di Dio, che scatta la inverosimiglianza della donazione. E quindi la visione ideale, esente da macchia, della Chiesa anima la stessa dimostrazione filologica e trasforma un testo apparentemente erudito in un’opera di denuncia contro il temporalismo della Chiesa reale e in un invito alla riforma: «Io non scrivo perché desideri perseguitare qualcuno […] ma per sradicare l’errore dalle menti degli uomini al fine di allontanarli, ammonendo o biasimando, dai vizi e dalle scelleratezze. […] Possa io, possa vedere un giorno […] che il papa sia soltanto vicario di Cristo e non anche di Cesare […]! Allora il papa sarà detto e sarà padre santo, padre di tutti, padre della Chiesa».
 Un modello di Chiesa modernissimo
Un modello di Chiesa modernissimo
L’orazione messa in bocca a papa Silvestro è un vero capitolo di teologia ecclesiale, basata sulla Sacra Scrittura, unico punto di riferimento, al di là dei precetti della tradizione ecclesiale, e interpretata con discernimento critico, in taluni passi anche contro la tendenziosa interpretazione di parte ierocratica. Quale è la vera chiesa a cui il Valla aspira, nella speranza di un rinnovamento, che auspica con cuore sincero e fiducioso? – La chiesa deve avere un unico fondamento, Cristo. – Sul modello di Cristo, il papa deve essere il buon pastore, che svolge nei confronti delle pecore del gregge una funzione di amorosa protezione, e non di comando né di giudizio – Sempre su modello di Cristo, il papa e la chiesa devono essere poveri e generosamente disinteressati, remoti da ogni cupidigia terrena – Ancora su modello di Cristo, il papa e tutta la chiesa devono concepire il potere solo come servizio, poiché, secondo le parole di Gesù, il regno di Cristo «non è di questo mondo». Gravemente assurda e scellerata, addirittura empia, l’assimilazione del regnum Dei al regnum seculare, della chiesa al potere temporale, sia nella sostanza, sia nelle manifestazioni esterne, le vesti sfarzose e la pompa degli ornamenti, di cui la chiesa si è via via addobbata nei secoli, allontanandosi anche in questo dall’umiltà delle origini Ma la chiesa deve anche essere libera. È questo uno degli aspetti più caratterizzanti l’ecclesiologia del Valla. Egli rivendica una duplice libertas ecclesie. Certamente la libertà da un potere politico “amico”, ma “condizionante”; certamente la libertà di culto.
Libertà di parola e di critica
Ma il Valla propone anche un altro tipo di libertà: non la libertà da nemici esterni ma la libertà interna alla chiesa. Grave peccato contro il diritto umano e divino farebbe l’Autorità se non rispettasse la «libertà di parola» e la «buona coscienza». Facendo appello e riferimento alla chiesa primitiva, in cui vivace e da tutti rispettata era la dialettica interna, tra Paolo e Pietro, il Valla richiede all’Autorità, senza paura, il riconoscimento della libertà di parola e di critica, quando sostenuta da retta coscienza, quando basata sulla verità onestamente ricostruita e del tutto squadernata, ad opera di uno storico-filologo competente, verità che, come tale, da chiunque conquistata, ha valore sacrale: poiché – il Valla lo ripete insistentemente – «la verità viene da Dio». Autorità e tradizione della chiesa non sono mai esenti da errori: come Pietro è stato giustamente ripreso su alcuni questioni da Paolo, così anche potranno essere giustamente sottoposte a critica false credenze della tradizione, sia pure portate avanti nella convinzione di “proteggere” il popolo di Dio da deviazioni o di confermarlo nella fede (l’attacco del Valla alle falsità pseudo-agiografiche e alle loro pseudo-giustificazioni è spietato), ma soprattutto potranno e dovranno essere sottoposte a critica, con libera contestazione, verità presentate come tali e come tali difese per secoli dalle somme autorità curiali in modo obbligante, quasi verità di fede, se prove circostanziate evidenti, tratte alla luce anche da laici preparati, ne dimostrino l’inconsistenza e la contraddizione. Il Valla sottolinea, in sostanza, come l’autorità ecclesiale non vada seguita in quanto tale, ma solo se agisce con virtù e saggezza, nel rispetto della veritas e dell’autentica iustitia.
La filologia applicata alla Bibbia
In tale ambito di emancipazione dall’autorità ecclesiale rientra anche la revisione della traduzione della Vulgata del Nuovo Testamento, condotta dal Valla lungo molti anni e diffusa, ad opera del suo grande estimatore Erasmo, dopo la sua morte. Siamo ovviamente un secolo prima della categorica assolutizzazione della Vulgata da parte del Concilio di Trento, ma anche all’epoca del Valla la traduzione attribuita a Girolamo era considerata l’autentico testo della Bibbia, come tale intoccabile; e in particolare, comunque, sussisteva l’idea che solo il clero potesse occuparsene. Il Valla rivendica invece la liceità del proprio operato, in nome delle proprie competenze di filologo, conoscitore del latino e del greco. In un passo importantissimo, preliminare ad un’altra opera, il De professione religiosorum, il Valla, capovolgendo l’obiezione che un laico grammaticus non sia idoneo ad occuparsi di realtà religiose, dichiara che chiunque può scrivere di teologia e religione purché ne abbia gli strumenti intellettuali e linguistici adatti, strumenti che un laico agguerrito come lui possiede alla grande e che invece proprio gli uomini di chiesa spesso non posseggono, ignoranti di storia, di lingua latina, di capacità espositiva, di aggiornata competenza teologica.
L’uguaglianza di tutti i cristiani
Risulta evidente da questo insieme di atteggiamenti valliani una straordinaria (per i tempi! e per tutti i tempi?…) valorizzazione dei laici nella Chiesa. Non troviamo in lui dichiarazioni esplicite circa il “sacerdozio universale”, che sarebbe stato formulato in quanto tale ben successivamente, ma certamente individuiamo la convinzione della uguaglianza di tutti i cristiani, chierici e laici, dinanzi a Cristo. Il tema emerge con chiarezza nell’appena menzionato dialogo De professione religiosorum Il Valla vi osserva che, secondo una tradizione ecclesiale consolidata, ma che egli individua come ingiusta, i frati ritengono di essere gli unici autorizzati a chiamarsi “religiosi” e quindi, implicitamente, si considerano i “veri” religiosi. Ma religioso in senso cristiano significa fedele in Cristo e chiunque abbia il dono di questa fede, e la incarni nelle opere conseguenti, è religioso. «Che cos’è essere religioso se non essere cristiano e veramente cristiano? […] al punto che è la stessa cosa religione e fede e religioso e fedele». È il battesimo che garantisce l’unione con Cristo, ogni altro legame è accessorio ed inutile, e non crea distinzione né di grado né di qualità. Ed è la fede il fondamento, senza il quale nulla nell’uomo è valido, ed è la fede la sorgente della salvezza, salvezza che viene da Cristo, a tutti gli uomini, per gratuita misericordia di Dio. Si potrebbe continuare, enucleando altri importanti elementi della teologia ed ecclesiologia valliane, sparsi in altre opere, filtrati poi, come quelli finora presentati, attraverso Erasmo e attraverso Lutero, nella religiosità europea. Ma quello che mi pare importante rilevare è che noi moderni non possiamo guardare questi scritti come a qualcosa che ci sia indifferente. L’ammonimento che deriva dalle parole del Valla è rivolto anche la chiesa di tutti i tempi. Perché rifugga da una tentazione in essa sempre latente: la tentazione del potere, sia al suo interno che verso l’esterno.
Mariangela Regoliosi Già professoressa di Filologia medioevale e umanistica presso l’Università degli studi di Firenze. Membro del Gruppo di Riflessione e Proposta dell’Associazione Viandanti.