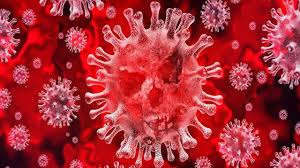credenti più gentili con le cose e con la terra
intervista a Antonietta Potente
a cura di Laura Badaracchi
in “Avvenire” del 31 maggio 2015

Si rivolge anzitutto a chi non conosce da vicino la vita consacrata, e a chi la guarda con diffidenza, l’ultimo saggio scritto dalla teologa Antonietta Potente, delle Suore domenicane di San Tommaso d’Aquino, edito dalle Paoline col titolo È vita ed è religiosa. Una vita religiosa per tutti. Dopo il dottorato in teologia morale e l’insegnamento a Roma e Firenze, ha vissuto per oltre un decennio in Bolivia con una famiglia di etnia Aymara, guadagnandosi il pane come docente all’Università di Santa Cruz e Cochabamba. Nelle pagine del suo nuovo libro si respira profumo conciliare. Chi professa i voti – dice fra le righe la religiosa di origine ligure, trapiantata a Torino – non è un superuomo o una superdonna, ma un battezzato e una battezzata che desidera vivere radicalmente il Vangelo: «Non siamo noi la liberazione e la salvezza, né degli eroi, ma dei compagni di viaggio». Che hanno ispirato i Padri e le Madri del deserto nei primi secoli del cristianesimo e oggi possono suggerire a tutti uno stile di vita alternativo, diventando una bussola in tempi di crisi etica, oltre che economica. Un discorso decisamente controcorrente.
In un mondo dominato da superficialità e approssimazione, lei invita a essere particolarmente attenti al soffio della vita e dello Spirito.
«Credo che il soffio debba rimanere una costante nella vita cristiana. Nel senso della precarietà, nella coscienza che – in fin dei conti – la vita in generale è qualcosa di molto bello e altrettanto sfuggevole, con dei limiti. Una costante che vale per congregazioni, gruppi, movimenti in cui si sente e si palpa questa fragilità dell’esistenza. Questa premessa del Vangelo sembra comunque accompagnarci sempre, sollecitando attenzione e sensibilità a quello che la storia e la realtà ci mostra come possibili cammini».
In che modo oggi la vita religiosa è chiamata a rinnovarsi per essere autentica? E come evitare le spinte verso un anacronistico ritorno al passato?
«Non ho delle risposte. Sono convinta che dobbiamo ritornare all’essenzialità più profonda: non è questione di esteriorità (rimettersi il saio, ripristinare la tonsura, ad esempio), ma di trovare un senso più evangelico che ci accomuna tutti, oggi come oggi. Tornare alle origini non dell’esteriorità, quindi, ma dell’essenzialità. La vita è fatta per ricercare il mistero, non per esserne sicuri, indipendentemente dalle varie scelte; per essere consapevoli e provare la passione di questa ricerca che è invisibile, soffio, Spirito. Si sceglie di consacrarsi a Dio per avvicinarsi non alle strutture, ma a una vita abbandonata alla gioia e alla precarietà».
Significa attualizzare i carismi delle diverse congregazioni?
«Bisogna guardare i disegni della storia: i carismi sono nati in un clima di consapevolezza evangelica, rappresentano una modalità con cui questa salvezza e gioia possono entrare nella vita di tutti, perché tutti ne possano beneficiare. Se le persone riescono a rendersi conto di questo, diventeranno fruttuose. Oggi le congregazioni più aperte hanno poche vocazioni, perché danno meno sicurezze ed esteriorità, hanno poche opere e lavori, scarsi posti di responsabilità».
Quale la contaminazione positiva tra la vita religiosa e quella dei laici?
«Siamo tutti chiamati, uomini e donne di ogni cultura, alla pienezza della vita. Credo che tutte le divisioni siano negative, a cominciare da quelle gerarchiche. Sappiamo che nella storia si sono create delle strutture che ci hanno separati, per quanto riguarda la partecipazione alla conoscenza del mistero. Pur mantenendo la diversità, lo specifico che è l’identità delle persone, bisogna riconoscere che la vita religiosa non è un ruolo, ma entra a far parte di donne e uomini consapevoli della loro sensibilità e passione. Invece, facendone quasi un mestiere – in passato anche con alcuni privilegi – abbiamo sbagliato. Le vocazioni vere non sono poche oggi: sono sempre state poche e nella Bibbia corrispondono a quelle profetiche. Nella comunità credente nella Chiesa alcuni uomini e donne percorrono questo cammino alla ricerca di una spiritualità specifica».
Afferma che la vita religiosa femminile ha dettagli che quella maschile non ha: cosa intende?
«Non siamo soldatini, non si tratta di arruolarsi ma di cercare la propria posizione nella storia, legare la vocazione alla propria identità. Ci sono delle mediazioni, io l’ho trovata nella spiritualità domenicana con la sua grande larghezza, nata nella consapevolezza che il Vangelo è di tutti. La categoria delle donne ha sempre appartenuto alle minoranze, con la consapevolezza di essere popolo, mentre gli uomini (da quando la vita religiosa è diventata anche sacerdotale) sono consapevoli di appartenere a una categoria. Essere popolo ha dato la possibilità di crescere vicine all’umano sia nelle relazioni comunitarie, sia nell’impegno missionario, affrontando le situazioni non solo in forma intellettuale. Invece la vita religiosa maschile ha avuto la grande fortuna di essere più dedicata allo studio della teologia».
Come s’intrecciano povertà, castità e obbedienza al rapporto cruciale con il creato?
«Vogliamo partecipare alla costruzione della storia (obbedienza), vivere relazioni non violente (castità), in una giustizia dignitosa senza assurde penitenze, alla ricerca del bene comune (povertà). Insieme impariamo che la terra non è nostra ma di tutti. Abbiamo abusato del creato perché diventasse denaro e merce. Se la vita religiosa fosse essenziale nei rapporti e sobria nelle scelte, dalla parte di coloro che ancora vogliono prendersi cura di un pezzo di terra, sarebbe possibile per i consacrati proporre uno stile esistenziale alternativo: la missione è questa, non andare a salvare gli altri ma testimoniare concretamente l’intensità del rapporto con Dio. Non bisogna essere tutti francescani per capire che in questo momento storico dobbiamo cambiare la relazione con le cose e la natura, renderla più gentile, meno prepotente e invadente. Questa è l’umiltà di stare nella storia: imparare a muoverci in questo deserto abitato con normalità, gioia e disponibilità. Perché la vita si salva se siamo davvero solidali».