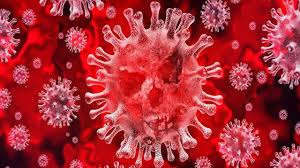di LELIO DEMICHELIS
Il nesso tecnologia/capitalismo è tornato recentemente alla ribalta, interpretato in termini ottimistici, nel fortunato libro di Paul Mason, “Postcapitalism” (che a breve uscirà anche in Italia). L’errore è pensare che la tecnologia abbia il potere di liberarci dal capitalismo. È piuttosto il contrario: è la tecnologia che permette al capitalismo di sopravvivere ai suoi problemi.
E’ arrivato un nuovo profeta che promette un postcapitalismo meraviglioso, umano, collaborativo, intellettuale, gratuito. Un postcapitalismo che sta nascendo dal capitalismo stesso e che, come il proletariato di Marx cancellerà questo capitalismo e ci porterà gioia, felicità, condivisione libera, la liberazione dalla fatica, eccetera eccetera. Perché si compia il passaggio al postcapitalismo basta confidare nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle nuove tecnologie, confidare nel loro potere liberatorio e liberante nonché libertario, nella loro capacità di diffondere nuovi modi di lavorare e di consumare liberando il tempo dal lavoro e permettendo a noi mortali attività in rete finalmente libere e quindi non capitalistiche. Basta credere che il web sia la nuova fabbrica e che svolga la stessa funzione delle fabbriche del XIX° secolo e che il suo proletariato digitale, diverso da quello industriale perché più informato e più connesso, possa abbattere questo capitalismo.
Tutto bello e affascinante. Dimenticando però che se il vecchio proletariato – che era classe in sé ma anche per sé avendo una propria coscienza di classe capace di fare contrasto al capitalismo – è stato ormai in-corporato nel (è parte del corpo politico e culturale del) sistema capitalista, si è progressivamente sciolto nel capitalismo e ne condivide l’egemonia, questo proletariato digitale è nato invece già antropologicamente capitalista, non ha alcuna idea di una possibile alternativa, ha assunto in sé l’imperativo della propria integrazione nel sistema (il dover essere connessi) e pur essendo forse ancora classe in sé (mai così tanti lavoratori precari, della falsa conoscenza, della sharing economy, taylorizzati e fordizzati in rete o uberizzati ovunque) non è classe per sé né potrà mai esserlo perché incapace di una coscienza comune e di una progettualità politica alternativa (perché è ormai convinto che: non ci sono alternative) in quanto ciascun componente di questo metaforico proletariato digitale è stato ormai separato, isolato dagli altri e messo in competizione con gli altri. Difficile immaginare la realizzazione di un postcapitalismo se ormai l’essenza della stessa società è il capitalismo più la tecnica. Difficile immaginare un’alternativa se ogni giorno il sistema ci educa ad essere capitalisti, se la rete stessa è oggi diventata puro capitalismo (in versione non 2.0 ma 0.0).
Eppure oggi circola questa nuova versione aggiornata – da Paul Mason, autore di quel Postcapitalismo che sta occupando le pagine di media pronti a dare voce ai tecno-entusiasti sempre e comunque e mai abbastanza – della vecchia favola del postcapitalismo che verrà. In realtà, leggendo Mason – che pure offre proposte decisamente interessanti e intriganti, come un mondo senza mercato, i banchieri centrali eletti democraticamente, il potere nelle mani della società civile, un reddito di cittadinanza, l’azzeramento (o quasi) del tempo di lavoro, la produzione di macchine beni e servizi a costi marginali nulli – sembra di fare un salto indietro nel tempo, a quando la rete era agli inizi ma già dimostrava la sua sconfinata potenza nel produrre retoriche per sé e per la sua accettazione di massa; a quando la rete era soprattutto una macchina capace di generare uno sconfinato e inarrestabile storytelling capace di abbattere ogni pensiero critico, ogni analisi razionale, ogni anticonformismo tecnologico; a quando la rete si trasformava da mezzo di comunicazione in mezzo di connessione di ciascuno nella rete, in modi simili alla vecchia catena di montaggio anche se globali e virtuali.
Leggere Mason fa l’effetto di un tempo che si è bloccato alle promesse della new economy degli anni ’90 del secolo scorso (che favoleggiava di fine dei fastidiosi cicli economici, prometteva la liberazione dalla fatica e un lavoro immateriale e intellettuale per tutti), alla fine del lavoro (1995) e all’era dell’accesso (2000) di Rifkin, alla wikinomics di Tapscott e Williams (2007), al punkcapitalismo di Matt Mason (2009), passando per l’Howard Rheingold della rete che ci rende intelligenti (2012), al Rifkin (ancora) della società a costo marginale zero (2014), ovvero all’internet delle cose, all’ascesa del commons collaborativo e quindi dell’eclissi del capitalismo. Senza dimenticare Negri e Hardt del Comune (2010). Per non citare che alcuni dei componenti di questo variegato mondo di profeti, di guru del post, abili nell’immaginare il nuovo regno di Dio-tecnica in terra, ma incapaci di fare preliminarmente una doverosa e foucaultiana archeologia dei poteri e dei saperi dominanti nelle società tecno-capitaliste. Quindi, incapaci di vedere come la soluzione da loro proposta per arrivare al postcapitalismo – più tecnologia che, da sola permetterebbe condivisione e libera circolazione delle idee – sia in contraddizione con l’essere la tecnologia ormai strettamente integrata al capitalismo (sono una cosa sola), la tecnologia permettendo al capitalismo di sopravvivere alle sue contraddizioni, il capitalismo essendo la benzina che permette alle nuove tecnologie di essere ciò che sono. Paradossale è dunque immaginare che quella tecnologia che sostiene il capitalismo e che lo ha reso globale (e globale e totalitaria la sua evangelizzazione) e che si serve del capitalismo per accrescere se stessa, possa giocare contro se stessa liberando se stessa (e gli uoimini) dal capitalismo che la sostiene.
Curioso: le ideologie o le religioni secolari del ‘900, che credevamo morte, sono in realtà più vive che mai e producono incessantemente nuove favole collettive, nuovi tecno-fideismi/tecno-integralismi che si offrono per dare un senso a un mondo apparentemente senza senso perché liquido, in realtà pesantissimo di connessioni obbligatorie, di incessanti pedagogie di adattamento non solo al mercato quanto alle nuove tecnologie. Che come le nuove tecnologie di vent’anni fa ci affascinano e ci promettono molto e continuamente cediamo alla loro richiesta di fede. Sanno di non avere mantenuto le promesse (meno lavoro, meno fatica, più libertà) e provano a rinnovare la promessa, chiedendoci di recitare nuovamente il loro Credo.
Ma cosa scrive Paul Mason, giornalista economico di simpatie laburiste, autore di libri di successo e ora di questo Postcapitalism, in uscita in traduzione italiana nei prossimi mesi? Che il capitalismo finanziario di questi ultimi anni – erede di quello industriale e di quello mercantile – avrebbe i giorni contati, posto che i mutamenti portati dalla rivoluzione informatica determinerebbero una modifica sostanziale dei modi di produzione e di consumo, metterebbero in discussione il sistema basato sulla legge della domanda e dell’offerta, della proprietà e dello scambio e lascerebbero progressivamente spazio ad una economia basata su tempo libero, attività in rete e gratuità.
Scrive Mason: «La tecnologia ha creato una nuova via d’uscita. Quello che resta della vecchia sinistra – e di tutte le forze che ne sono state influenzate – si trova di fronte a una scelta: imboccare questa strada o morire. Il capitalismo non sarà abolito con una marcia a tappe forzate ma grazie alla creazione di qualcosa di più dinamico, che inizialmente prenderà forma all’interno del vecchio sistema, passando quasi inosservato, ma che alla fine aprirà una breccia, ricostruendo l’economia intorno a nuovi valori e comportamenti. Lo chiameremo postcapitalismo».
Questo processo sarebbe già iniziato, grazie a tre grandi cambiamenti:
1) le nuove tecnologie «hanno ridotto il bisogno di lavoro, rendendo meno netto il confine tra lavoro e tempo libero e meno stringente il rapporto tra lavoro e salario». Vero, ma questo non ha liberato il lavoro, semmai lo ha reso indistinguibile dalla vita (quindi siamo meno liberi), ha moltiplicato ritmi e intensità del lavorare e ha favorito forme di lavoro e di sfruttamento (quasi) senza retribuzione mentre, cancellando la distinzione tra vita e lavoro (effetto diretto delle nuove tecnologie) ha prodotto una società a mobilitazione tecno-economica totale e permanente;
2) l’informazione «sta erodendo la capacità del mercato di determinare i prezzi in modo corretto. I mercati si basano sulla scarsità, mentre l’informazione è abbondante. Il meccanismo di difesa del sistema è formare monopoli – le grandi multinazionali tecnologiche di oggi – su una scala che non ha precedenti negli ultimi duecento anni. Ma questo non può durare (…) perché contrasta con il bisogno fondamentale dell’umanità di usare le idee liberamente». Assolutamente falso: il mercato sa benissimo come determinare i prezzi in modo corretto (per i propri profitti), grazie a delocalizzazioni, precarizzazione, sfruttamento, espropriazione della conoscenza altrui e condivisa, taylorismo digitale e rete e usa proprio le nuove tecnologie per farlo, come è altrettanto falso credere che l’informazione e la conoscenza siano abbondanti (siamo piuttosto in una società della semplificazione, non della conoscenza), la conoscenza e l’informazione sono sempre meno libere e sempre più controllate dai motori di ricerca, oltre ad essere fonte (Big Data) di alti profitti per pochi, mentre monopoli sempre più grandi sono sempre più grandi proprio perché noi permettiamo loro di esserlo sempre di più e perché è nella natura di un capitalismo non controllato;
3) stiamo assistendo «a una crescita spontanea della produzione condivisa: nascono beni, servizi e organizzazioni che non rispondono più ai principi del mercato e della gerarchia manageriale»; ma anche questo è falso, ormai il mercato è ovunque e in ogni relazione umana (il neoliberismo vive in ognuno di noi come una consolidata disciplina dentro una consolidata biopolitica), il lavoro è sempre più merce e sempre più sfruttato – a meno di considerare produzione condivisa la sharing economy, l’uberizzazione del lavoro, il dover essere imprenditori di se stessi. Certo, ancora Mason: «Quasi inosservati, nelle nicchie e negli angoli più nascosti del sistema di mercato, interi settori economici stanno cominciando a prendere un’altra strada. Monete parallele, banche del tempo, cooperative e spazi autogestiti sono spuntati come funghi», ma in verità sono anni che ci raccontiamo questa bella storia e ciò che è nascosto e inosservato resta nascosto o ai margini, non riesce a scalfire la potenza di fuoco del tecno-capitalismo, oppure si fa parte del sistema come le banane del commercio equo e solidale al supermercato. Intanto i beni comuni vengono aggirati dalle logiche di mercato (come in Italia per l’acqua, nonostante il referendum) e la sharing economy è comunque sotto forma di impresa e agisce secondo il mercato, socializzandolo.
Mason si rifà a Marx e al suo Frammento sulle macchine, all’idea di un intelletto generale, «una sorta di mente collettiva collegata attraverso la conoscenza sociale, in cui ogni progresso va a beneficio di tutti. In breve, Marx immaginava qualcosa di molto simile all’economia dell’informazione in cui viviamo oggi. E aggiunge che la sua venuta farà saltare in aria il capitalismo». Ma è evidente – dovrebbe essere evidente – che l’intelletto generale di Marx non è qualcosa di simile all’economia dell’informazione e soprattutto non farà saltare in aria il capitalismo proprio perché l’economia dell’informazione e della conoscenza è basata anch’essa sulla suddivisione/individualizzazione del lavoro e poi sulla sua integrazione/totalizzazione in qualcosa che è sempre e comunque alienato dal lavoratore stesso e alienante il lavoratore, sia esso uberizzato o lavoratore della conoscenza e dell’informazione.
Ci vuole ben altro, allora, per uscire dal tecno-capitalismo. Occorre una destrutturazione di tutti i meccanismi eteronomi e anti-democratici di messa al lavoro degli uomini (mercato e tecnica); una liberazione dai vincoli di connessione (di rete e mercato) e di alienazione; un anticonformismo digitale; una laicizzazione della società contro l’integralismo religioso del tecno-capitalismo; una separazione netta (ma decisa dagli uomini, non dalle macchine posto che la loro logica è quella dell’uso esaustivo del tempo e della produttività da accrescere sempre e comunque), tra tempi di vita e tempi di lavoro. Ma occorre soprattutto una riconsiderazione radicale (un rovesciamento) dei rapporti tra economia (che deve tornare ad essere un mezzo) esocietà (che deve tornare ad essere il fine).
Bibliografia essenziale
Demichelis L. (2015), La religione tecno-capitalista, Mimesis, Milano.
Formenti C. (2011), Felici e sfruttati, Egea, Milano.
Hardt. M.- Negri A. (2010), Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano.
Ippolita (2014), La Rete è libera e democratica. Falso!, Laterza, Roma-Bari.
Mason M. (2009), Punkcapitalismo, Feltrinelli, Milano.
Mason P., Postcapitalismo (in uscita da il Saggiatore nel 2016)
Morozov E. (2014), Internet non salverà il mondo, Mondadori, Milano.
Rampini F. (2014), Rete padrona, Feltrinelli, Milano.
Rheingold H. (2013), Perché la rete ci rende intelligenti, Cortina, Milano.
Rifkin J. (1995), La fine del lavoro, Baldini&Castoldi, Milano.
Rifkin J. (2000), L’era dell’accesso, Mondadori, Milano.
Rifkin J. (2014), La società a costo marginale zero, Mondadori, Milano.
Tapscott D. (2011), Net generation, FrancoAngeli, Milano.
Tapscott D. – Williams A. D. (2007), Wikinomics, Rizzoli-Etas, Milano.
(8 ottobre 2015)