«nessun castigo. Dio cura la vita»
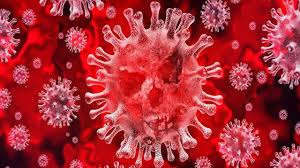
intervista a Franco Giulio Brambilla
a cura di Giacomo Gambassi in “Avvenire” dell’8 aprile 2020
a colloquio con il vescovo teologo Brambilla
«No alla superficialità di chi esce di casa senza ragione o fa discorsi astratti sul diritto di andare in chiesa»
Definisce la pandemia una «crisi drammatica, forse la più grave dopo il secondo conflitto mondiale». Accusa «gli sciacalli» che la leggono come un «castigo di Dio». Invita a fare di questo tempo di “deserto” fra le mura domestiche l’occasione per passare dall’« homo faber », ossia schiavo del fare, all’« homo religiosus » che sa riscoprire la dimensione spirituale. Denuncia «la superficialità di alcuni che uscivano sconsideratamente di casa senza necessità o che facevano discorsi astratti sul diritto di andare a pregare in chiesa, magari non andandoci di solito». E parla di una Quaresima 2020 che «ci ricorderemo» non solo perché «la data è facile da memorizzare» ma perché va considerata «come la più autentica della nostra vita».
Il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, non ha certo “tagliato” la sua agenda per l’emergenza coronavirus. Ogni sera il vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale ha proposto una video-meditazione via web e social. Sabato scorso ha guidato la veglia online dei giovani. E il Triduo pasquale lo vedrà impegnato (quasi) come al solito. A tutto ciò si aggiungono telefonate, scritti, iniziative di prossimità.
«Ogni giorno dobbiamo far prevalere la vita sulla morte, la consolazione sulla depressione, la mitezza sulla forza, la fiducia sulla dispersione, la condivisione sull’egoismo, la speranza sulla disperazione – afferma il vescovo teologo, profondo conoscitore della Scrittura –. Questa è la Pasqua di Gesù. Non è solo un happy end, un “…e vissero felici e contenti”. Ma la grazia della vita risorta».
Eccellenza, la pandemia interroga sul silenzio di Dio?
Molti si pongono la domanda sul “silenzio di Dio” solo nel tempo di una grande prova. Questa crisi pone una questione lancinante: dov’è Dio? Però non ci mettiamo in questione, quando “non lasciamo parlare Dio” nel momento del benessere. Provo a pensare cosa significa che “Dio fa silenzio”. Forse significa che Dio non dà risposta al nostro dolore, alle nostre paure ed ansie? Ma il silenzio di una persona non è forse lo “spazio bianco” tra le sue parole, perché possano essere intese con chiarezza e profondità e trovino il tempo di calare nel nostro cuore? Non sono le “linee bianche” tra una riga e l’altra sulle pagine della Sacra Scrittura, perché la sua Parola ci raggiunga come pane sapido e nutriente? Una persona che parla senza pause è insopportabile, una pagina senza linee bianche è illeggibile. Dio sta in silenzio quando non ascoltiamo la sua Parola. Il silenzio di Dio è il respiro della sua Parola.
Ci può fare un esempio?
Ho fatto un’esperienza semplice in questa Quaresima: quattro settimane, tutte le sere, collegato in streaming, per 15 minuti di preghiera sulle letture del giorno. Eccome se Dio ha parlato! Ha dato voce al nostro tormento, alle nostre domande, alle nostre ansie, alla nostra preghiera: talvolta bisognava difendersi dalla ricchezza inesauribile della sua Parola. E la gente è rimasta fedele all’appuntamento. Non possiamo interrogarci sul silenzio di Dio, se non lo lasciamo parlare nelle opere e nei giorni della vita quotidiana, perché allora ci circonderà di un “silenzio assordante”. Il silenzio di Dio, quello vero, è lo spazio che nella fede facciamo ogni giorno per rendere la sua Parola presente alla nostra vita, senza addomesticarla. Parola di Dio, silenzio parlante, fede orante: questa è la sfida e il dono di questi giorni. Provare per credere.
È possibile una lettura teologica di quest’emergenza sanitaria?
Alcuni parlano di punizione. «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?», si legge nel Vangelo di Giovanni. Quando si abbatte su di noi una tragedia, che stravolge il nostro quieto vivere e il nostro delirio di onnipotenza, allora scatta il senso di colpa. Chi ha frequentato un po’ di storia della spiritualità riconosce questo filone apocalittico, che minaccia castighi per ogni tempo. Certo nella Bibbia c’è il tema dell’ira divina, ma non è che l’altra faccia della misericordia: Dio censura il nostro agire malvagio, mettendoci in guarda da cosa ci succede se viviamo in un mondo dell’accumulo sfrenato, della concorrenza sleale, della sfruttamento forsennato, del divertimento egoistico… E ci dice: «Perché ho misericordia di te, come fa un padre buono, ti dico che, se fai così e così, vai a finire male tu, la tua casa e la tua vita; ma tu mi stai a cuore e per me sei più importante anche delle tue azioni malvagie. Perciò ho misericordia di Te». Dio non vuole la morte del peccatore, ma che egli viva. Nessun castigo, ma cura per la vita e il destino dell’uomo-
Viviamo in restrizione fra le mura domestiche. Capiremo come usare meglio la nostra libertà?
Dipenderà da noi. Tutti oggi si affannano a dire: «Non sarà più come prima». E ci somministrano consigli. Ma molti hanno sperimentato che vivere rinchiusi in casa non è semplice: può smascherare la nostra aggressività, far emergere le nostre paure, insofferenze, spigolosità, l’incapacità a fare spazio all’altro. V’è però anche una possibilità diversa: che si scopra un’altra dimensione dell’uomo, che non è solo homo faber, che produce e capitalizza, ma anche homo ludens, che gioca, canta, crea, dipinge, suona, scrive, racconta. Anzi, ancor meglio, può diventare homo religiosus, cioè uomo o donna dei buoni legami (da re-ligare), che sa ascoltare, parlare, dialogare, pensare, pregare, lodare, invocare, consolare, amare, sperare. Sì, questo è il “sacrificio” più bello, perché “rende sacro” l’essere della nostra libertà. Non è forse questa la sfida più intrigante di questi giorni? Di fronte a migliaia di morti in Italia, tornano a irrompere nella società la fragilità umana e il mistero della morte? Fragilità, vulnerabilità, mortalità. La grande illusione forse è stata quella di averle censurate e rimosse. Ma esse stavano accovacciate alla porta della nostra casa. Ed è bastato un nemico invisibile, democratico, che non guarda in faccia a nessuno, per risvegliarle come un mostro. La prolixitas mortis degli antichi è sparita dal nostro orizzonte e ci ha fatto nascondere la testa sotto la sabbia: pensiamo che la morte, e con essa la nostra fragilità, sia affare degli ultimi giorni della vita. E non, come dice la sequenza di Pasqua, che «la morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello».
Il picco del Covid-19 ha coinciso con la Quaresima. Non c’è il rischio di una Pasqua “triste”?
Sono giunto all’età di cui il Salmo dice: «Settant’anni la vita dell’uomo, ottanta per i più robusti» (Sal 90,10). Il noto esegeta L. Alonso Schökel traduceva: settant’anni sono un dono, il resto una mancia. L’ho scritto all’inizio della mia Lettera pastorale di quest’anno: Il laccio del sandalo. Non avrei mai pensato che potesse significare questo: una Quaresima e una Pasqua di pura gratuità!
Papa Francesco ha sottolineato che «non ci si salva da soli». Il virus abbatte l’indifferenza?
C’è chi forse non ha capito la gravità eccezionale della situazione, mentre moltissimi medici, infermieri, operatori, amministratori, lavoratori, sacerdoti hanno dato la vita. Ma proprio questo ha suscitato storie commoventi di dedizione e di amore. L’icona indimenticabile è quell’infermiera crollata dal sonno sulla tastiera del tavolo di lavoro. Già si parla del “dopo”. Che cosa resterà? Si potrebbe dire: io speriamo che me la cavo… È presto per dirlo. Intanto, fin quando non ci sarà il vaccino non potrà essere come prima. Perché «nella prosperità l’uomo non comprende, è simile alle bestie che muoiono» (Sal 49,21). Bisogna che egli impari sempre da capo la sapienza della vita, lasciandosi ammaestrare dalla Parola che respira nel silenzio di Dio









 «Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato»
«Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sani in un mondo malato»









