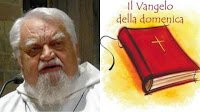Mt 23,1-12
In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati «rabbì» dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare «rabbì», perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate «padre» nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare «guide», perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato.
il commento di ENZO BIANCHI al vangelo della domenica trentunesima del tempo ordinario (5 novembre 2017):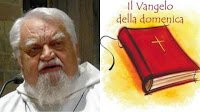
Nel vangelo secondo Matteo, dopo diversi scontri e controversie tra Gesù e scribi, sacerdoti, farisei (cf. Mt 21,23-22,46), durante il suo ultimo soggiorno a Gerusalemme, egli pronuncia un lungo discorso, il penultimo, prima di quello escatologico. Si tratta di una raccolta di invettive e di ammonizioni indirizzate da Gesù proprio a quei suoi avversari che tante volte lo avevano contraddetto, gli avevano teso tranelli, lo avevano messo alla prova, lo avevano calunniato e insidiato con giudizi e complotti. Questo discorso, registrato al capitolo 23, è duro, e può meravigliarci di trovarlo sulla bocca di chi con misericordia perdonava i peccatori, mangiava con loro e li faceva sentire amati da Dio, anche se non meritavano tale amore. Gesù – possiamo dire – attacca i legittimi pastori del suo popolo, i dirigenti, quelli che erano riconosciuti esperti delle sante Scritture, che erano ritenuti maestri e modelli esemplari per i credenti. Sia però chiaro che queste sue parole vanno a colpire vizi religiosi non solo giudaici ma anche cristiani!
E si faccia attenzione: Gesù non fa di tutta l’erba un fascio, non si scaglia contro i tutti i farisei, tutti i sacerdoti, tutti i maestri, ma contro coloro che in quel preciso tempo dominavano, erano al comando; contro quelli che lo accuseranno, lo perseguiteranno e, dopo averlo condannato, lo consegneranno ai pagani per l’esecuzione capitale. Dunque, questi rimproveri non vanno applicati generalizzando, ma vanno ripetuti per noi cristiani, noi che nella chiesa svolgiamo una funzione e sovente siamo ritenuti “uomini e donne di Dio”, secondo il linguaggio corrente.
Ma ascoltiamo con piena obbedienza le parole di Gesù, che così apre il suo discorso: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro azioni, perché parlano ma non realizzano ciò che predica”. C’è una cattedra del popolo di Dio, c’è un ministero, un servizio reso ai credenti, ossia il compito di proclamare la parola di Dio contenuta nella Torah data da Mosè a Israele nel deserto, dopo la liberazione dall’Egitto. Il Dio che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù ha anche dato al suo popolo la Torah, l’insegnamento, affinché conoscesse la sua volontà e fosse dunque un popolo di testimoni capaci di proclamarla a tutte le genti.
Dopo Mosè, molti e diversi sono stati i maestri, dotati di un magistero per il popolo, ma quanti in quel momento storico (30 d.C.) erano i dirigenti e le guide religiose, abitualmente insegnavano in modo conforme alla tradizione ma in loro non c’era coerenza di comportamento, perciò mancavano di autorità (exousía). Predicavano ai fedeli ma in realtà non osservavano quanto dicevano. Erano persone divise, che con le labbra dicevano una cosa ma con il cuore ne pensavano altre (cf. Mt 15,8; Is 29,13). Fare e osservare sono le espressioni con cui il popolo ha scelto il Signore, ha ripudiato gli idoli e ha sancito con lui l’alleanza: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo ascolteremo” (Es 24,7), ovvero “lo comprenderemo nella misura in cui lo metteremo in pratica”.
Tale promessa doveva valere tanto più per i capi del popolo del Signore, e invece costoro esaurivano la realtà nella sua proclamazione verbale. In profondità non ascoltavano, perché chi ascolta il Signore obbedisce. Ma essi preferivano sentire la parola del Signore per predicarla senza invece ascoltarla, senza fare l’esperienza della faticosa realizzazione della volontà di Dio attraverso un intelligente discernimento e un’azione piena di carità. Succede anche a noi di dire e poi di non agire conseguentemente, ma lo dobbiamo confessare ai fratelli e alle sorelle, senza pretendere di essere esemplari se non siamo coerenti nel nostro comportamento reale e quotidiano: siamo peccatori e ciò non va nascosto! Gesù definisce questo comportamento “ipocrisia” e lo condanna, perché di fatto favorisce una cecità su se stessi, fino a credere di vedere e addirittura a giudicare gli altri come ciechi (cf. Gv 9,41). Costoro fingono, recitano una parte senza essere né convinti né conseguenti.
Segue un’altra accusa: “Legano fardelli pesanti e difficili da portare e li impongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito”. Qui Gesù intravede la funzione assunta da scribi e farisei: spiegare la Legge, determinare il comportamento, interpretare il comando emanando precetti. E così la parola di Dio, data come Torah, insegnamento, diventava gravida di prescrizioni legali minuziosissime: in partenza lo scopo era quello di porre una siepe attorno alla Legge per custodirla, ma di fatto questi precetti umani finivano per essere pesi imposti sulle spalle soprattutto dei piccoli e dei semplici, pesi e fatiche che loro, i pretesi legislatori, non conoscevano e certamente non portavano. Di fatto, in tal modo si annullava la parola di Dio, la si eludeva con abilità, si svuotava il comando dato dal Signore (cf. Mc 7,8-13; Mt 15,3-6)…
Ma la lettura di Gesù va più a fondo: “Tutte le loro azioni le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange”. Questo è il vizio di chi pensa di avere un potere sugli altri e vuole dunque mostrarlo, per essere riconosciuto dalla gente: farsi vedere per testimoniare la fede, a fin di bene, per educare gli altri e dare il buon esempio… Quante volte questi atteggiamenti coprono intenzioni squallide e menzognere! Le testimonianze devono essere lette da chi vede e ascolta, non date da chi dovrebbe solo vivere, senza fare narrazioni di sé e delle proprie azioni: saranno gli altri, con il loro discernimento, a giudicare la verità o la falsità di chi deve parlare solo del Signore, non di se stesso. Questo esibizionismo religioso purtroppo è tanto presente, ancora oggi, nelle nostre chiese!
Di seguito Gesù menziona alcuni status symbol, tanto amati perché utili a creare consenso. Quelli che il Signore aveva chiesto come segni (’ot), diventati filatteri (tephillin, da tephillah, “preghiera”), anziché ricordare a chi li portava il Dio liberatore (cf. Es 13,9.16; Dt 6,8; 11,18), finivano per essere sempre più vistosi perché gli altri li ammirassero (come quelli che tirano fuori dalle tasche in mezzo agli altri un rosario, per essere considerati uomini o donne di preghiera!). Non solo, costoro allargavano anche le frange, cioè i fiocchi (tzitzit) nel loro mantello di preghiera, non per ricordarsi di Dio (cf. Nm 15,37-41), ma per farsi ammirare come uomini di preghiera. È la perversione di strumenti dati da Dio per confermare la fede e l’ascolto la sua parola e invece divenuti, attraverso un meccanismo perfido, strumenti per ricevere applausi e onori!
E così ecco la conseguenza: “Amano i posti d’onore nei banchetti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati ‘maestri’ dalla gente”. Quando si esercita l’autorità, si è facilmente preda di queste tentazioni: si è ossessionati dalle vesti, si è abbigliati come quelli che stanno nei palazzi del potere (cf. Mt 11,8; Lc 7,25), e magari si afferma di comportarsi così solo per dare gloria a Dio e prestigio alla chiesa, professando una falsa umiltà. Sappiamo che sotto vestiti ricercati e orpelli sontuosi si nascondono ecclesiastici umilissimi o poveri: non si tratta dunque di dare giudizi sulle persone, ma di indicare dati oggettivamente in contraddizione con il modo di vivere di Gesù, richiesto a chi fa riferimento al suo Nome. D’altra parte, è sempre valida l’osservazione di Yves Congar:
Si può beneficiare ordinariamente di privilegi senza arrivare a pensare che sono dovuti? O vivere in un certo lusso esteriore senza contrarre certe abitudini? E essere onorati, adulati, trattati in forme solenni e prestigiose, senza mettersi moralmente su un piedistallo? È possibile comandare e giudicare, ricevere uomini in atteggiamento di richiesta, pronti a complimentarci, senza prendere l’abitudine di non più veramente ascoltare? Si può trovare davanti a sé dei turiferari senza prendere un po’ il gusto dell’incenso?
E qual è il luogo migliore per apparire se non i pranzi e le cene con quelli che in questo mondo contano? Cene e ricevimenti che forniscono un autocompiacimento egocentrico, occasioni nelle quali risuonano grandi e altisonanti titoli onorifici, svolazzanti fasce colorate… Allora il titolo era “rabbi”, “maestro” (non ancora termine tecnico per indicare gli attuali rabbini); oggi ce ne sono molti di più, mediati dalla mondanità più banale: si pensi per esempio a “eccellenza”, titolo estraneo nella chiesa fino al secolo scorso e poi mutuato dal fascismo, che chiamava “eccellenza” i prefetti…
Dobbiamo dirlo: sovente siamo caduti nel ridicolo, e oggi molti leggono tante ostentazioni ecclesiastiche come vuote e controproducenti; ma la cecità è tale che tutto sembra continuare come nelle corti bizantine o rinascimentali, se si esclude qualche eccezione. E invece nella comunità cristiana ogni titolo deve significare ciò che viene realmente vissuto, non deve essere un orpello onorifico. Per questo Gesù avverte i suoi discepoli: “Ma voi non così, non fatevi chiamare ‘rabbi’, perché uno solo è il vostro Maestro (didáskalos) e voi siete tutti fratelli. E non chiamate ‘padre’ nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre (patér) vostro, quello nei cieli. E non fatevi chiamare ‘guide’, perché uno solo è la vostra Guida (katheghétes), il Cristo”. Il discepolo di Gesù è avvertito: rabbi e guida sono titoli che vanno applicati solo a lui, il Cristo di Dio, così come solo Dio va invocato quale Padre. Parole nette, chiare, alle quali però raramente si è rimasti fedeli, perché già nella chiesa antica si sono definiti padri quelli che hanno generato a Cristo nella fede fratelli e sorelle e sono stati chiamati maestri e guide quanti erano incaricati dell’insegnamento e del discernimento spirituale nella comunità cristiana.
Ciò che è decisivo in questo avvertimento di Gesù si trova alla fine del nostro brano: chi è più grande o chi è il primo della comunità cristiana – e ci deve essere chi è più grande, chi presiede i fratelli e le sorelle – sia servo di tutti, si abbassi e si spogli di ogni potere e arroganza, sull’esempio di Gesù, il Servo del Signore, e così sarà innalzato (cf. Fil 2,5-11). Altrimenti sarà abbassato, deposto dal trono, retrocesso nel banchetto celeste. A questo punto Gesù continua ad ammonire scribi e farisei fino alla fine di questo capitolo, pronunciando i sette “guai”, che non sono maledizioni ma avvertimenti, aspri richiami in vista della conversione, invettive e lamenti pronunciati da chi continua a sperare che i destinatari di queste parole possano fare ritorno a Dio. In ogni caso, dovremmo leggerli facendo memoria del commento di Girolamo: “Guai a noi, miserabili, che abbiamo ereditato i vizi degli uomini religiosi!”.