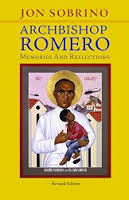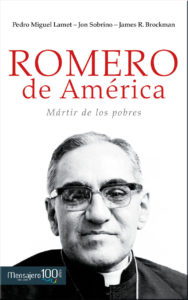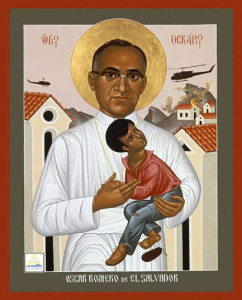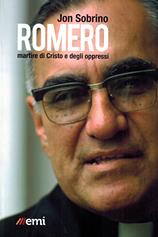J. Sobrino e la pandemia

cosa si pensa e come si parla di Dio nella pandemia
Jon Sobrino
da: Adista Documenti n° 24 del 20/06/2020

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato due mesi fa: «Questa è la sfida più grande che abbiamo affrontato dalla Seconda Guerra Mondiale». Quindi, secondo le sue parole, la maggiore crisi che ha avuto luogo sul pianeta in quasi un secolo. Il suo accento è caduto sulle vittime: «I più vulnerabili (donne e bambini, disabili, emarginati e sfollati) pagano il prezzo più alto. I rifugiati e altri sfollati per conflitti violenti sono doppiamente vulnerabili». E ha avanzato due richieste: «Mettere fine alla malattia della guerra e lottare contro la malattia che sta devastando il nostro mondo».
Affinché queste parole ci scuotano come dovrebbero, è bene ricordare che il numero di vittime della Seconda Guerra Mondiale è stato calcolato tra i 55 e i 60 milioni. E, per capire fino a che punto possa arrivare l’orrore di una pandemia – ovviamente sperando che ciò non avvenga –, bisogna considerare che, nel 1918-1919 la cosiddetta Spagnola causò almeno 50 milioni morti e circa 500 milioni di persone contagiate, un terzo della popolazione mondiale. La pandemia è un male particolare. È un orrore. In un primo momento può generare un timore paralizzante, ma, soprattutto, produce indignazione e dolore, ed esige l’impegno a trovare una soluzione finché non sia scomparsa del tutto. Non si deve dimenticare. E non produce alcun bene ignorare il suo orrore recitando il Padre nostro: liberaci dal male, libera nos a malo. Nel giorno in cui sto scrivendo, 15 maggio, nel mondo si riportano 4.477.351 contagiati, 303.389 morti, 1.606.796 guariti. In El Salvador 1.112 contagiati, 23 morti, 405 guariti. Nella stampa salvadoregna si legge in questi giorni: «Un milione e mezzo di persone protestano per non aver ricevuto i 300 dollari». «La miseria colpisce il centro di San Salvador ». «La quarantena porta le famiglie a chiedere cibo». «Negli ultimi quattro giorni sono state assassinate 19 persone». «Per la fine dell’anno si potrebbero perdere fino a 1.200 milioni di dollari». «A rischio 20.000 posti di lavoro». E così via. E soprattutto situazioni psicologiche di insicurezza totale, dolore senza consolazione, sfiducia paralizzante, separazione all’interno delle famiglie… Voglio terminare affrontando un tema di cui oggi penso che non si parli molto. È il tema di Dio, “la questione Dio”. Non è la questione della religione, né quella della Chiesa o delle Chiese. Neppure la questione di Gesù Cristo. Forse il lettore rimarrà sorpreso. Ma spero comprenda la mia decisione di parlare di questo tema, spero con onestà e lucidità e sicuramente con il desiderio che porti del bene. Farò, allora, alcune riflessioni su Dio, e più in concreto su come si sta pensando e si sta parlando di Dio oggi. E terminerò con una riflessione personale su Dio, anche in tempo di pandemia.
Una questione con una lunga storia
Nel corso della storia, in diverse culture e religioni, si è pensato a Dio in differenti modi. Ma l’esistenza del male, di qualcosa di cattivo o di molto cattivo, ha spesso condotto a pensare a Dio in maniera particolare. Certamente ciò è dipeso da catastrofi come Auschwitz o il terremoto de Lisbona. In tali riflessioni sorge solitamente quello che è stato chiamato il problema di Dio e che io, più pacificamente, definisco la questione di Dio. In qualunque caso, è Dio a venir fuori, ed è comprensibile.
Il tema è complesso e per nulla facile da trattare. Ma è importante rendersi conto ed essere coscienti di cosa ne è di Dio e di cosa resta di Dio in questa lunga storia di modi di pensare e di dibattere. A seguire, senza molte spiegazioni, mi fermerò a constatare i diversi modi in cui si è parlato e si parla di Dio soprattutto in tempi difficili. Il lettore noterà la grande varietà di modi di parlare e di pensare, che possono giungere anche a contraddirsi. Nel prossimo paragrafo, non esprimerò giudizi su questi modi diversi, mi limiterò a prenderne atto.
Un po’ di storia. Dov’è Dio, che fa e che non fa. Il terremoto di Lisbona
Avvenne nel 1755, producendo un’enorme distruzione. Nel ricordarlo, in questi giorni qualcuno ha scritto, e a mio giudizio non senza ragione, che quello di Lisbona «sarebbe stato solo un altro terribile terremoto… se non fosse che ebbe un impatto più sulle menti che sui corpi». In effetti, questo terremoto ha fatto sì che il pensiero razionale soppiantasse il dogmatismo più rigido. Non avvenne in maniera automatica. I pensatori cattolici dell’epoca (quasi tutti lo erano) seguivano le idee di Leibnitz, secondo cui, se compie la volontà di Dio, l’essere umano «vive nel migliore dei mondi possibili».
Se qualcosa va male in questo mondo, sarà stato per volontà di Dio, ma come castigo per il male commesso dagli esseri umani. Voltaire, tra gli altri, si oppose a questa giustificazione di Dio, a questa teodicea.
Il dilemma di Epicuro
Tornando al terremoto di Lisbona, l’implicazione più importante fu quella di interrogarsi su Dio con libertà, quale che fosse la conoscenza a cui tale libertà avrebbe condotto, con ciò sollevando un dubbio su Dio e, più concretamente, su un Dio al tempo stesso potente e buono. Si tornava così al dilemma attribuito fin dall’antichità a Epicuro, riguardo all’esistenza di un Dio che è buono, che non vuole il male e che ha il potere di evitare il male. Dinanzi a quanto avviene nel mondo, la conclusione obbligata sarebbe la seguente: “Se Dio è buono non è onnipotente. E se è onnipotente non è buono”.
Con questa logica Epicuro non dimostrava la non esistenza di Dio, ma poneva radicalmente in discussione attributi di Dio ritenuti evidenti per secoli: la sua onnipotenza e la sua bontà, il suo amore nei confronti degli esseri umani.
Nel corso della storia, grandi pensatori – come Tommaso d’Aquino con le sue vie per arrivare a Dio – hanno cercato di dimostrare l’esistenza di Dio, pur ammettendo i mali di questo mondo. E specificamente si sono sforzati di dimostrare che Dio non è responsabile di tali mali. Ora è sufficiente ricordarlo. La ragione rimane, o può rimanere, in pace. Ma può anche restare inquieta.
Terremoti, terrorismo e barbarie in tempi vicini
Nel 2002, su richiesta della casa editrice Trotta di Madrid mi posi, in un piccolo libro intitolato Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, l’interrogativo su dove sia Dio: alcune riflessioni – poi riproposte nel 2003 in un libro della Uca Editores – a proposito delle catastrofi che avevano avuto luogo in quei giorni. In El Salvador, il 13 gennaio del 2001, c’era stato un forte terremoto. A New York, l’11 settembre dello stesso anno, aveva avuto luogo l’attentato alle torri gemelle. L’Afghanistan viveva anni di terrorismo. E per onestà, con la speranza che pure vedevo, aggiunsi una riflessione sull’utopia.
La preghiera e l’eccesso di credulità
In Paesi come El Salvador, tanto in mezzo alle serie difficoltà della vita quotidiana come ora nella catastrofe del coronavirus, Dio è invocato assai spesso dai poveri e anche dai preti. Si chiede a Dio che ci aiuti, risani, conforti e consoli i contagiati e tutti coloro che sono in stato di bisogno. Gli si chiede anche di mantenere in forze, e in vita, quanti se ne prendono cura. E di premiarli.
Ma con o senza pandemia, penso che la questione della fede in Dio non venga solitamente affrontata come un problema importante. Più concretamente, nel mondo dell’abbondanza molti possono vivere tranquillamente senza occuparsi di Dio, del fatto che ci sia o meno. E, non ponendosi il problema, neppure si preoccupano molto di dimostrare la sua esistenza. Prima c’erano atei che si interrogavano sulla responsabilità di Dio nei mali di questo mondo, concludendo: “la giustificazione di Dio è che non esiste”. Ora non è più dato ascoltare tali ironie. Con o senza catastrofe, la teodicea, che letteralmente significa “giustificazione di Dio”, oggi non è più così importante. Né credo che se ne parli qualche volta nelle chiese, nelle aule dei seminari, nell’infinità di riunioni dell’infinità di movimenti delle Chiese.
Abbandono di Gesù sulla croce da parte di Dio
Personalmente, è da anni che non mi attraggono le liturgie che parlano molto del potere di Dio e che insistono ripetutamente e unilateralmente sulla sua bontà e sulla sua misericordia. In questi giorni abbiamo potuto ascoltare che Dio ci accompagna sempre, che possiamo sempre riporre in Lui la nostra speranza, che Dio non ci inganna mai.
Permettetemi una digressione. Nel Vecchio Testamento Dio ha potere, che usa solitamente a favore del popolo eletto e a volte contro di esso, se non si comporta bene. Molto spesso sconfigge i nemici di Israele, molti dei quali a volte vengono distrutti. Nel Vecchio Testamento però appaiono anche altri modi di procedere da parte di Dio. I canti del servo di Isaia presentano un Dio il cui potere non consiste nello schiacciare e il cui servo è portatore di salvezza non distruggendo l’avversario ma lasciandosi sconfiggere da esso.
L’abbandono di Dio
Alcuni giorni fa, nell’eucarestia celebrata da papa Francesco nella cappella di Santa Marta è risuonato il salmo 22 con il noto lamento: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? », così come viene raccolto dal vangelo di Marco. Papa Francesco, a modo suo, ha affrontato tale questione nella sua omelia. E si è chiesto cosa faccia Dio dinanzi a tanta sofferenza.
Da molti anni ho l’impressione che nella teologia, nella liturgia e non so se anche nella pastorale, parlando della morte di Gesù, si sorvoli assai rapidamente sul racconto di Marco – e poi di Matteo – in cui Gesù muore con il lamento del salmo 22 sulle labbra. Con maggiore facilità si affronta il racconto di Luca, in cui Gesù muore recitando un altro salmo, più fiducioso, dicendo «nelle tue mani affido il mio spirito». E meno problemi offre il vangelo di Giovanni, in cui Gesù muore con una certa solennità, padrone di se stesso, dicendo: «tutto è compiuto». Di fatto, Gesù ha dovuto morire senza pronunciare parole, se non con un grido per l’asfissia provocata dal fatto di essere in croce. Grido che menzionano tutti i sinottici.
Penso anche che si parli con grande facilità del fatto che l’orrore della croce di Gesù esprima l’amore infinito di Dio. Il Padre ha sacrificato suo figlio Gesù, non lo ha risparmiato. E così siamo stati salvati. Poi lo ha esaltato e lo ha reso Signore per essersi consegnato a una morte in croce.
Dinanzi all’orrore della croce non mi pacificano queste affermazioni, né mi pacifica il riferimento alla resurrezione di Gesù come una specie di lieto fine. Con questa inquietudine dinanzi alla facilità con cui si evita di affrontare il tema di Dio e della croce, già molti anni fa scrissi un breve articolo sulla rivista Sal Terrae dal titolo “Il risorto è il crocifisso”. Il risorto è la dimensione trascendente e il crocifisso è quella storica. E sono più incline a intendere il trascendente partendo assai esplicitamente dallo storico che viceversa.
Queste riflessioni non sono di grande attualità, e non è facile, almeno per me, svilupparle. Ma non posso evitare di pormi tali questioni. Possono stranire o almeno sorprendere. Possono disgustare. Ma le pongo sul tappeto perché, in definitiva, l’inquietudine che possono produrre può generare a sua volta una pace diversa, maggiore, più calma.
Il Dio crocifisso di Moltmann
È il titolo di un libro di Jurgen Moltmann. Quando i gesuiti vennero assassinati alla UCA, portarono il cadavere di Juan Ramón Moreno nella mia stanza che era vicina, poiché io mi trovavo in Thailandia. Nel trambusto, dallo scaffale della mia stanza cadde il libro di Moltmann Il Dio crocifisso e rimase impregnato del sangue di Juan Ramón. Inviai a Moltmann una foto del suo libro insanguinato. Alcuni anni dopo venne a visitarci. Nella Sala dei Martiri si fermò a guardare il suo libro insanguinato, e terminò la sua visita nel Giardino delle rose, dove rimase a lungo.
Il grande contributo di Moltmann è quello di affermare che Dio è toccato dalla sofferenza. Lo ha dimostrato con audacia e – a mio giudizio – con sufficiente lucidità. Onnipotente o no, Dio è toccato dalla croce. E l’enigma della croce di Gesù non si chiarisce, non si trasforma in mistero, facendo appello alla resurrezione.
Precedentemente, Moltmann già era diventato famoso per un altro libro intitolato Teologia della speranza. Tuttavia, sotto l’impatto di un Dio crocifisso introdusse la croce nella sua teologia della speranza. «Non ogni vita è motivo di speranza, ma sì lo è la vita di chi per amore si è preso carico di una croce ». Personalmente, trovo assai illuminante questo modo di esprimere la speranza che proviene da Gesù.
Il Dio crocifisso di Dietrich Bonhoeffer
Al lettore di Carta a las Iglesias credo che Bonhoeffer non sia molto noto. È stato un pastore della Chiesa luterana e un grande teologo. È stato tra i primi a parlare di secolarizzazione ed è diventata famosa la sua frase che bisogna vivere etsi Deus non daretur, come se Dio non esistesse. Ed è stato un martire la cui figura appare ora sulla facciata della cattedrale di Westminster insieme a quella di monsignor Romero. Il 9 aprile si è celebrato il 75.mo anniversario della sua morte in un carcere di Berlino. Dopo aver partecipato a un complotto, fallito, per eliminare Hitler, Bonhoeffer fu arrestato e impiccato su esplicita richiesta di Hitler. In prigione, il 18 luglio del 1944, scrisse questi versi: «Gli esseri umani nel loro dolore arrivano a Dio, implorano aiuto, chiedono felicità e pane, che salvi dalla malattia, dalla colpa e dalla morte i loro cari. Questo lo fanno tutti, tutti, tutti, cristiani e pagani. Gli esseri umani si avvicinano a Dio nel dolore di Dio, e lo trovano povero, insultato, senza difese, senza pane, lo vedono vinto e morto per il nostro peccato, oh, Signore!».
I cristiani rimangono con Dio nella passione
Quando molti anni fa lessi questi versi in classe, scese un silenzio come non ne ricordo altri. Neppure quando ricordavo che Dio aveva resuscitato suo Figlio si creava un simile silenzio. Per parlare cristianamente della relazione tra le vittime e Dio, mi pare importante relazionare entrambe le realtà a una pericoresi, compenetrazione. Significa che bisogna porre Dio nelle vittime: divinizzazione delle vittime. E che bisogna porre le vittime in Dio: vittimizzazione di Dio.
La novità dei martiri della pandemia
Questa novità si rivela chiara soprattutto nel popolo crocifisso generato dalla pandemia, la quale non è derivata dalla volontà umana, ma dalla natura, come i terremoti. E le cui vittime possono superare in numero quelle di altre catastrofi prodotte della volontà umana. E tale novità è chiara anche nei martiri gesuanici, le persone che, per prendersi cura dei contagiati, soffrono disagi, stanchezza, problemi, malattia e morte: familiari, personale medico e infermieristico, religiose, preti, volontari e volontarie.
Solo un dato. In Italia la notizia del coronavirus ha cominciato a pesare sul clero il 15 marzo. Molti preti hanno iniziato ad aiutare i contagiati in diversi modi. In due-tre settimane circa 60 di loro sono morti. Personalmente mi ricordano san Luigi Gonzaga. Molti anni fa ce lo ponevano come modello di giovane gesuita per le sue virtù, insistendo sulla castità e sulla modestia. Anni dopo venni a sapere che era morto a Roma il 21 giugno 1591 a 23 anni per essersi preso cura dei malati di peste.
L’eredità dei martiri della pandemia
Penso che l’eredità di questi martiri sia la stessa di tutti gli esseri umani che hanno perso la vita innocentemente. Alcuni di loro, i martiri gesuanici, sono stati uccisi per essersi presi cura dei bisognosi, per aver difeso gli oppressi, le vittime della repressione. Tutti questi martiri proclamano l’ovvia verità di Gesù: «Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i fratelli» (Gv 15,13). Il martirio si relaziona primariamente all’amore, e ai suoi derivati fondamentali. Oggi, alla giustizia e alla dignità. E si relaziona primariamente al sacrificio dei martiri, unificando nel modo migliore l’amare e il dare la propria vita. E in un’altra maniera ciò avviene anche con i popoli crocifissi. Ho scritto che in loro c’è stata una santità primordiale.
Come Dio passa per questo mondo. Passa con ciò che è insolito
In questi giorni di coronavirus l’ambiente religioso pullula di parole e di scritti su cose strane, su cose che non avvengono nella quotidianità: ricordi di apparizioni celesti, di uomini, donne, bambini e bambine, soprattutto, a cui è stato concesso di vedere e di fare prodigi impossibili al resto dei mortali. E non manca chi in questi giorni ha visto una luce tra le nuvole trasformata in una croce.
Qui in El Salvador, il 13 maggio, giorno della vergine di Fatima, una sua immagine ha percorso il territorio nazionale in elicottero. Il tragitto si è prolungato per più di sei ore. Lo hanno organizzato gli Araldi del Vangelo. «Ci è sembrato interessante e speciale festeggiare, perché la Vergine benedica le persone contagiate e non contagiate di tutto il Paese». Il sacerdote responsabile ha espresso il desiderio che i salvadoregni ricevessero le loro benedizioni dal cielo e la cura miracolosa per questa malattia. Sembrano sognare e desiderare che Dio passi per questo mondo di pandemia come non lo ha fatto quando passò per questo mondo con Gesù di Nazaret.
«Con monsignor Romero Dio passò per El Salvador»
Ma il passaggio di Dio non è stato sempre visto in questa maniera esotica, bensì in un’altra assai diversa. «Con monsignor Romero Dio passò per El Salvador», disse Ellacuría. E spiegò molto bene ciò che voleva dire. «Monsignore fu un inviato, non un mero prodotto delle nostre mani. Diventò – non per tutti ugualmente – il grande regalo di Dio, e un regalo molto speciale». E proseguì: «I saggi e i prudenti di questo mondo, ecclesiastici, civili e militari, i ricchi e i potenti di questo mondo, dicevano che faceva politica. Ma il popolo di Dio, quelli che hanno fame e sete di giustizia, i puri di cuore, i poveri con spirito, sapevano che tutto questo era falso. Mai avevano sentito Dio così vicino, lo spirito così evidente, il cristianesimo così vero, così pieno di grazia e di verità».
Permettetemi un’ultima digressione. Recentemente ho pubblicato un libro in cui ho parlato della mia oscurità dinanzi a Dio, negli Stati Uniti e in Germania, lunga circa dieci anni, senza trovare pace. Però, di ritorno a El Salvador, apparvero i poveri e apparvero i martiri, i martiri gesuanici e il popolo crocifisso. E Dio si affacciò. In questi poveri e in questi martiri Dio non si mostrò con evidenza, come un raggio di luce, né come la solidità della roccia. Tuttavia, con il permesso di san Giovanni della Croce, – e senza la sua altezza poetica – rimase in me «un non so che» che continua ad affacciarsi. Che si senta Dio così vicino, lo spirito così reale e il cristianesimo così vero, questa è l’eredità dei martiri. Questa è l’eredità di coloro che sono vissuti e sono morti come Gesù. Ed è l’eredità del popolo crocifisso che vive più poveramente di Gesù.
Con pandemia o senza pandemia, con questi uomini e queste donne, con il nostro fratello Romero, Dio passa per El Salvador.